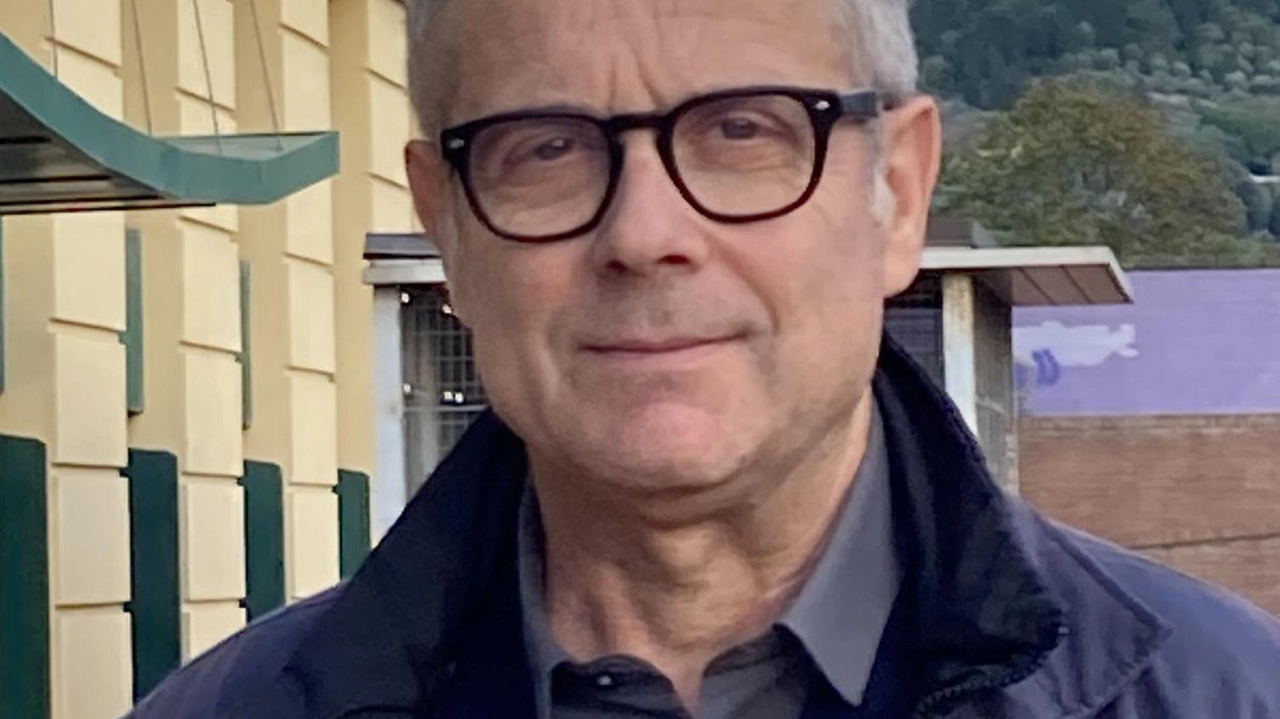
Fanfani, urbanista e docente all’Università di Firenze, ha coordinato lo studio "Realizzare il Parco significa mettere in opera un elemento primario e non di compensazione". Rientrano nell’area anche Prato, Carmignano e Poggio .
Prato, Carmignano e Poggio a Caiano: tre Comuni della nostra provincia rientrano nel Progetto di Territorio per il Parco Agricolo della Piana. Gli altri sono Calenzano, Campi Bisenzio, Sesto Fiorentino e Signa e per una piccola parte Firenze. Il progetto del Parco, che comprende un sistema di ben 8mila ettari, è spalmato di fatto su tutta la riva destra d’Arno. David Fanfani, pianificatore urbanista e docente al dipartimento di Architettura dell’Università di Firenze, ha coordinato proprio uno studio sul Parco. Realizzato nel 2024, è stato commissionato dalla Regione Toscana. Alla viglia della presentazione e della firma del Patto per la cura e la tutela del Parco Agricolo della Piana (sarà sottoscritto oggi pomeriggio a Villa San Lorenzo a Sesto Fiorentino), cercato di capire meglio un progetto che vuole essere fondamentale per le politiche presenti e future del territorio.
Professore, può spiegarci l’importanza del progetto? "Ho accettato l’incarico di questo studio con piacere nella convinzione che realizzare il Parco agricolo significhi mettere in opera un elemento primario e non di compensazione che, come indicato nel Piano di Indirizzo Territoriale Regionale (PiT) costituisce un Progetto di Territorio "ordinatore di tutte le politiche territoriali dell’ambito interessato". Insomma, non ha un ruolo subordinato".
Entriamo nel dettaglio: perché serve questo Parco? "E’ un progetto di salvaguardia attiva delle aree periurbane agricole che lega il recupero dell’agroecosistema anche a nuove forme di economia del territorio".
Insomma, può generare sviluppo. "Esatto, il contesto del Parco Agricolo della Piana comprende un sistema di ben 8.000 ettari - articolato su 8 comuni - di aree a caratterizzazione prevalentemente agricola ed ambientale. Aree che hanno importanti dotazioni sia in termini di patrimonio storico-culturale ed ecologico ma che sono dotate anche anche di attività agricole, con numerose aziende che operano anche in forma innovativa, ad esempio in termini di biologico e di rapporto con il mercato locale. Le cosiddette filiere corte. Ci sono più di 300 aziende agricole che lavorano in quest’area".
Quali sono gli ambiti tematici chiave immaginati per il Parco e le possibilità di sviluppo ad esso collegate? "Ad esempio la creazione di un sistema di accessibilità e ricettività per la fruizione ‘lenta’ del patrimonio culturale ed ambientale, inclusi i piccoli borghi storici della piana. Un sistema connesso con gli ambiti circostanti e sovralocali. Fondamentale è poi lo sviluppo di un sistema locale del cibo su cui molti comuni stanno già lavorando, anche tramite la realizzazione di un ‘food hub policentrico’. Un altro ambito è l’agricoltura ‘no food’, in relazione con le tradizioni produttive locali. Significa coltivare piante non solo destinate all’uso alimentare ma ad altri tipi di manufatti, come l’edilizia sostenibile, ad esempio".
Tra gli ambiti chiave mette anche il tessile. "Esatto. Andiamo nel concreto: a Prato si coltiva il lino, ma non viene poi trasformato, questo viene fatto altrove, quindi occorre agire sulla filiera. Tra gli altri ambiti tematici chiave cito ad esempio quello della rigenerazione e del potenziamento del sistema di reti della biodiversità".
Chiudiamo gli occhi. Come possiamo immaginare il parco? "Credo che il progetto potrebbe funzionare bene creando delle ‘porte’, snodi di servizio e accesso, come possono essere ad esempio le Cascine di Tavola o il Consorzio agricolo di Sesto, luoghi che offrono servizi. Nel quadro europeo questo potrebbe essere uno dei parchi più multifunzionali".
Quali strumenti di policy o pianificazione ritiene fondamentali per garantire che il parco agisca non solo come contenitore, ma come motore attivo di sviluppo? "In Europa i parchi agricoli funzionano se esistono altri elementi: una designazione e destinazione d’uso che protegga queste aree, un piano di sviluppo del parco e un soggetto che lo gestisca e ne abbia cura. Noi al momento siamo al primo punto".
Come immagina la governance del Parco? Quale soggetto deve gestirlo? Con quali competenze e con che modalità? "Si è convenuto con la Regione l’ipotesi di un partenariato pubblico-privato, una governance partecipata".
Quali misure concrete sono previste per sostenere le produzioni locali e delle filiere corte nel progetto del Parco? "La prima misura è che in una gestione di prospettiva del parco vengano tutelate le aree agricole. Se noi vogliamo convertire le produzioni al biologico, ad esempio, dobbiamo far sì che il contadino abbia un contratto stabile. L’idea di fondo del Parco è di sistema che si integra con le diverse città della piana e ne esalta ed espande i valori di urbanità e bellezza, ma anche ne regola le scelte di trasformazione, proponendo la visione alla scala metropolitana di una città compiuta ed un modello integrato di sviluppo locale. Ad alcuni sfugge la concretezza e rilevanza di questa visione, anche di tipo economico e anche per affrontare le sfide del cambiamento climatico. Tuttavia si tratta di una ipotesi estremamente realistica, basata sull’ascolto del territorio e dei suoi attori, delle sue molte criticità e anche sulla individuazione di un possibile modello gestionale di partenariato pubblico/privato".
Maristella Carbonin

