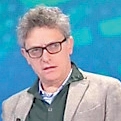Lo psicologo e la scienziata affrontano il delicato tema: dalla legge Basaglia alle speranze di investimenti
Psicologo, giornalista e conduttore radiofonico, Massimo Cirri, sabato 30 agosto, insieme alla scienziata Leor Zimgrod, sarà protagonista di ‘E tu, hai un cervello ideologico?’ appuntamento del Festival della Mente che ha suscitato tanta curiosità tra il pubblico da essere poi stato proposto in doppia replica. Durante il dialogo, con approccio multidisciplinare, verrà mostrato l’intreccio invisibile tra le nostre convinzioni e la biologia del cervello, spiegando perché alcuni possono essere più sedotti di altri dalle ideologie.
Cirri, nel suo campo che peso hanno le ideologie? "Mi è capitato spesso di trovarmi di fronte a dinamiche che hanno a che fare con il tema che verrà affrontato nell’incontro. Parlo delle difficoltà evidenti di persone che stanno soffrendo e che si devono arrabattare per uscire da un periodo complesso. Anche nei casi di depressione si possono vedere le differenze tra le persone che hanno una mentalità rigida, che hanno più difficoltà a rimettere in sesto la proprio vita dopo un duro colpo, come può essere un lutto o la perdita del posto di lavoro. Ma accade anche che persone rigide, messe di fronte a un trauma o a uno shock, possano cambiare il loro modo di pensare. Anche se devo dire che in questo periodo storico il pensiero rigido e ideologico, sembra essere quello vincente".
La salute mentale è stata per molto tempo un tema invisibile. "Quelli che erano definiti “matti“ sono stati per anni internati, confinati, annullati. Sappiamo che Franco Basaglia ha impiegato dieci anni per tradurre in legge quella rivoluzione intrapresa a partire dal 1961 dall’interno del manicomio di Gorizia e che ha poi portato, nel 1971, alla chiusura dei manicomi.
Quello spartiacque cos’altro ha determinato? "Il cambiamento di base è lo sguardo con cui guardiamo le persone che prima erano considerate solo come un disturbo e viste come aliene. Ora sappiamo che esiste certo una differenza, ma è come se fossimo seduti sulla stessa panchina. C’é la consapevolezza che la sofferenza di quella persona sia fatta delle stesse ragioni della mia vita. Il matto non è sostanzialmente diverso da me, è un me più angosciato e turbato e, anche se dentro ha un demone, rimane un uomo. Faccio un esempio concreto. Mettiamo che un ragazzo abbia una crisi psicotica e stia distruggendo casa, se si interviene in massa in maniera brusca, questo ragazzo ci metterà mesi o anni a riacquisire fiducia nei confronti di chi lo ha preso con forza. Se invece come accaduto a Trieste, quando un medico e un infermiere con pazienza infinita hanno impiegato 12 ore per convincere un ragazzo a farsi aiutare, l’effetto sortito sarà migliore. Non parlo solo dell’effetto sul paziente, ma anche sul costo dell’intervento che immediatamente sarà maggiore, ma a lungo termine, riducendo il rischio di futuri ricoveri in psichiatria e recidive, potrebbe rappresentare un risparmio".
Lei ha lavorato per venticinque anni nel servizio pubblico di salute mentale. Cosa c’è di buono? E cosa invece potrebbe migliorare? "Di buono c’è che un po’ della visione Basaglia è passata. Se nostro figlio ha una crisi, sta male o è agitato, consideriamo la situazione estenuante, ma non pensiamo a rinchiuderlo in un posto chiuso. Oggi, con tutte le difficoltà del caso, tutti i paesi della Toscana e anche nel Lazio, sono dotati di un servizio di salute mentale sempre attivo. Esistono tantissimi posti. Da qualche anno esistono anche in Italia anche delle sorte di sindacati, portati avanti da persone che sono uscite da un periodo complesso e che mettono a disposizione degli altri il loro sapere e la loro esperienza. Da cambiare ci sarebbe l’organizzazione dei servizi, capire quanto ci interessa e quanto vogliamo investire in salute mentale e più in generale in sanità. È assurdo che l’aspettativa di vita di un cittadino calabrese sia più bassa di 2 anni e 6 mesi rispetto a un trentino, perché lì i servizi sono migliori".
La salute mentale oggi è ancora invisibile nell’agenda politica italiana? "Sono ormai trent’anni che siamo a chiamati a votare sull’immigrazione, che è certo un tema. E non sull’istruzione che vorremmo, sui servizi, o sulla sanità. L’Oms ha raccomandato agli stati membri di mettere in piedi servizi di salute mentale come quelli che esistono a Lille in Francia, a Curitiba in Brasile e a Trieste, dove esistono ben 4 spazi a cui rivolgersi sempre. Ma a Milano, una delle principali città italiane, dopo le 17, se qualcuno dovesse avere bisogno, potrebbe rivolgersi soltanto a 6 reparti dell’ospedale".