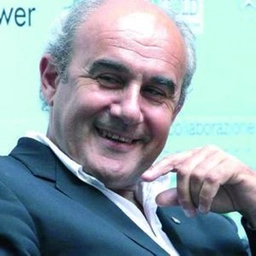Da Suarès a D’Annunzio alla leggenda della fonte: la chiesa buca i secoli ma il capolavoro rinascimentale lotta col degrado .
Brilli
L’ultimo dei rondò creati nella viabilità aretina nel settore meridionale della città rende agevole, per non dire invitante, l’accesso alla chiesa di S. Maria delle Grazie, al suo celebre porticato e alla sua loggia. Un tempo il luogo dove sorge il complesso monumentale era appartato e denso di memorie a cui la lontananza conferiva un’aria di magica evocazione. Il turista frettoloso, che di norma ignora questo luogo, dovrebbe rammentare le parole di un viaggiatore il quale, diversi anni or sono, parlava di "una chiesa deliziosa, un vero gioiello nascosto fra le vigne". E ricorderebbe soprattutto quelle del raffinato scrittore francese André Suarès il quale, negli anni Trenta del secolo scorso, annotava nella sua relazione di viaggio: "Ad Arezzo ho dormito sotto le stelle, al riparo del porticato di S. Maria delle Grazie. Come ho amato quegli archi e le loro esili colonne!". Sostando sotto il loggiato antistante la facciata della chiesa, nei primi del Novecento Gabriele D’annunzio aveva fatto del luogo l’ideale punto di osservazione di Arezzo e del suo circondario. I suoi versi sembrano la traduzione verbale dello sguardo che, facendo perno sulla città, scorre istintivamente tutto attorno, da una catena montana all’altra, elencandone i nomi parlanti: "Bruna ti miro dall’aerea loggia / che t’alzò Benedetto da Maiano. / Fan ghirlanda le nubi ove Lignano / e Catenaia e Pietramala poggia". Con l’annesso convento e una cappella, la chiesa era sorta in forme gotiche fra il 1435 e il 1444, a ridosso della collinetta di Pitigliano, per volere di Bernardino da Siena, nel luogo dove un tempo sgorgava una fonte che il popolo riteneva miracolosa, capace di sanare i mali più diversi, e dove c’era una selva che si diceva fosse abitata da un oracolo vaticinante. Si trattava evidentemente di credenze e di culti pagani duri a morire, tanto è vero che la fonte miracolosa era detta sin dall’antichità fons tecta, cioè fonte coperta, opportunamente custodita. Con spirito che oggi non stenteremmo e definire “talebano”, nel 1428 Bernardino infiamma la fede del popolo aretino a tal punto da spingerlo ad impugnare roncole, pale e badili per distruggere la fonte miracolosa e abbattere la selva incantata. La storia di questa crociata del santo senese, noto per analoghe, deleterie campagne contro le più varie, importanti testimonianze dell’antichità classica romana, è stata illustrata da Lorentino d’Andrea in un dipinto che si trova nella chiesa di San Francesco.
Su progetto di Giuliano da Maiano, di fronte alla chiesa di S. Maria delle Grazie venne organizzato un ampio piazzale cinto da un quadriportico, esempio più unico che raro di piazza porticata destinata ad accogliere i pellegrini e ad ospitare fiere e mercati. Il grande piazzale e l’ampio basamento della scalinata mettono in risalto l’elemento più geniale e raffinato del complesso, il loggiato che Benedetto da Maiano, fratello di Giuliano, antepose alla chiesa con una leggerezza che ha dell’incredibile. In calcolato contrasto con gli alti pulvini, la cesura degli abachi taglienti fa degli archi e delle colonne della "aerea loggia" uno degli esempi più alti dell’architettura rinascimentale, quasi un’esasperazione dell’eleganza. All’interno della chiesa, sistemata entro un monumentale, elaborato altare di Andrea della Robbia, ad attendere il pellegrino c’è la Madonna della Misericordia, opera giovanile di Parri di Spinello che la dipinse nel 1428. La figura alta e frontale della Vergine, severa come un idolo, ha un sapore arcaico che viene appena stemperato dai vivaci colori dei fedeli, divisi nei due sessi e raccolti sotto l’ampio mantello. Oggetto di serena visione per chi, venendo dalla città, si affaccia al quadriportico, la loggia di Benedetto da Maiano offre una veduta altrettanto mirabile.
La "bruna" città di D’annunzio appare oggi in buona parte nascosta dai nuovi insediamenti e solo nell’immaginario vediamo il gran bastimento del duomo navigare sulla ghirlanda di nubi e contro i monti, lontani confini del suo territorio e ultimi echi della sua storia. Vorremmo chiudere qui la riflessione sul complesso di S. Maria delle Grazie, se le sue attuali condizioni non lasciassero sgomenti. Infatti l’insieme comunica a prima vista un indefinito senso di desolazione. Sciogliendo la mente dalle memorie di un tempo, ci si accorge che il lato del portico, a sinistra della chiesa, ha il tetto sconnesso e la parte muraria fatiscente, infatti una fettuccia rossa e bianca, legata alla meglio alle colonne, segnala il divieto di accesso. Come se non bastassero l’usura del tempo e l’incuria delle istituzioni sacre e profane, si è voluto deturpare questo straordinario esempio di eleganza trasformando lo spazio antistante "l’aerea loggia" in un campetto di calcio con tanto di porte contrapposte. Non sembra che sia il modo migliore per tutelare quello che gli storici dell’arte considerano il primo esempio di piazzale porticato realizzato in epoca rinascimentale fuori delle mura di una città.