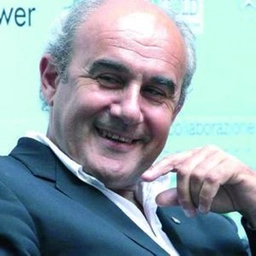"Aspetto centrale dei miei studi è la cosiddetta sinapsi immunologica, un punto di contatto speciale che si crea quando due...
Aspetto centrale dei miei studi è la cosiddetta sinapsi immunologica, un punto di contatto speciale che si crea quando due cellule del sistema immunitario si incontrano: da un lato un linfocita T, dall’altro una cellula che gli mostra il ’nemico’ da combattere, come un virus o un batterio. L’incontro è indispensabile: è qui che il linfocita T riceve il segnale per attivarsi, moltiplicarsi e organizzare una risposta mirata contro la minaccia", così Francesca Finetti inizia la spiegazione di ’IS-APDS’, la ricerca che coordina presso il Dipartimento di Scienze della vita.
Cosa sta dietro alla sigla IS-APDS?
"I due aspetti centrali del progetto: IS, è l’abbreviazione di sinapsi immunologica, mentre APDS indica una malattia genetica rara che colpisce il sistema immunitario, la sindrome da attivazione di PI3K. L’APDS è causata da mutazioni genetiche che rendono la proteina PI3K sempre attiva, anche in assenza di stimoli esterni. Questo porta al funzionamento anomalo del sistema immunitario: da un lato non riesce a difendere l’organismo, favorendo infezioni frequenti, dall’altro può reagire in modo eccessivo contro i propri tessuti determinando lo sviluppo di malattie autoimmuni e, in alcuni casi, contribuire allo sviluppo di tumori del sistema linfatico".
Ci spieghi.
"Il progetto si concentra sullo studio, in pazienti affetti da APDS, della sinapsi immunologica, il punto di contatto attraverso il quale le cellule del sistema immunitario comunicano tra loro permettendo l’attivazione della risposta immunitaria. Nei pazienti con APDS l’attivazione del sistema immunitario è alterata, ma la formazione della sinapsi immunologica non è stata ancora studiata. Con questo progetto vogliamo capire in che modo le mutazioni presenti influenzano la sinapsi immunologica a livello molecolare, così da chiarire i meccanismi della malattia, individuare possibili biomarcatori per prevedere l’andamento dei sintomi e valutare l’efficacia delle terapie. Attualmente le opzioni terapeutiche per l’APDS sono ancora limitate, ma esistono farmaci promettenti in attesa di approvazione in Italia come il leniolisib, testato in questo progetto".
Durata e modalità della ricerca?
"Il progetto è nato grazie alla collaborazione con il professor Vassilios Lougaris, ricercatore medico e professore in Pediatria dell’Università di Brescia, e con la professoressa Cosima Baldari dell’Università di Siena. L’attività di ricerca coinvolge anche Leandro Marzuoli, studente della scuola di Dottorato in Scienze della Vita. Ha durata di due anni ed è finanziato da Unisi nell’ambito del bando New Frontiers 2024".
Ci sono già risultati, evidenze?
"Sì, risultati promettenti: nei pazienti con APDS la sinapsi immunologica mostra alterazioni a livello molecolare. Attualmente stiamo sviluppando un modello in vitro della malattia: linfociti T che esprimono la versione normale o mutata della proteina PI3K. Questo ci permetterà di approfondire i meccanismi alla base della malattia e di capire meglio l’impatto delle varianti genetiche sulla formazione della sinapsi immunologica. I risultati potrebbero anche aiutare a spiegare perché i sintomi dell’APDS variano tanto da un paziente all’altro".