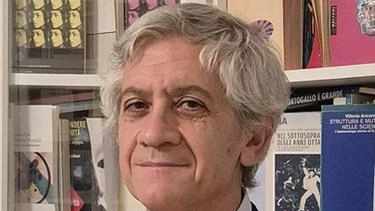
Pippo Russo (Università di Firenze)
FIRENZE
Gli ultimi dati Eurostat segnalano che meno del 12% dei conduttori di aziende agricole UE ha un’età inferiore ai 40 anni. La panoramica sulla realtà degli altri continenti non segnala tendenze molto differenti, ma ciò che in modo particolare rende fragile la realtà europea è l’età media della sua popolazione: 44,7 anni, con l’Italia che segna il più elevato tasso di senilizzazione (46,8 anni secondo i dati Eurostat 2020, ma con tendenza all’innalzamento stando ai dati più recenti). Di questa criticità è pienamente consapevole la Commissione Europea, che per iniziativa del lussemburghese Christophe Hansen, commissario per l’agricoltura e l’alimentazione, fa delle politiche di ricambio generazionale uno dei punti strategici. L’urgenza è avvertita anche dal governo nazionale italiano e dagli enti territoriali periferici, con la Toscana particolarmente sensibile. Ne parliamo con il professor Pippo Russo, ricercatore di Sociologia dell’Ambiente e del Territorio presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Firenze.
Professor Russo, per cominciare: la situazione italiana è davvero così critica?
"E’ critica ma con tratti di ambivalenza. I dati Eurostat che fanno riferimento alle classi d’età fino a 35 anni danno qualche segnale di controtendenza. Risulta che soltanto il 6,5% dei conduttori di aziende agricole italiane rientra in questa fascia d’età; un dato in calo rispetto al 7,3% della rilevazione 2005, ma anche in ripresa sul 5,9% del 2016. Va da sé che quel segnale di ripresa va rafforzato con politiche di supporto che aiutino a rimuovere i blocchi al ricambio generazionale".
Appunto, i blocchi: quali sono quelli che pesano in misura principale?
"Bisogna distinguere fra gli ostacoli all’ingresso dei giovani e quelli all’uscita degli anziani. Sul versante dei giovani troviamo le difficoltà di accesso alla terra agricola e al credito, ma conta molto anche la mancanza di un capitale di esperienza maturata sul campo, che è un fattore immateriale spesso decisivo per una nuova azienda agricola. Se invece guardiamo al versante degli agricoltori anziani, la loro uscita è ostacolata innanzitutto dal livello molto basso delle pensioni di anzianità, che di fatto impediscono di smettere di lavorare. Inoltre, in molti casi la casa in cui abitano si trova nella terra agricola dell’azienda, ciò che rende impossibile il distacco. Infine, c’è un aspetto di carattere sociologico: non è affatto un luogo comune che l’agricoltore non si ritiri mai davvero dal lavoro, coincide con la sua vita, impossibile scindere".
Lei ha curato uno studio specifico per la Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale della Regione Toscana. Risulta che il modello dell’azienda familiare rischia di essere l’anello debole del sistema.
"Va fatta una precisazione. Il modello familiare è stato la spina dorsale del sistema agricolo italiano. Ma in questa fase storica rischia di essere il punto di maggiore fragilità. Il mix di crisi demografica e migrazione dei giovani verso la città pone una situazione per cui si è già a rischio di esaurire le linee di successione nelle aziende familiari. Questo rischio colpisce particolarmente il sistema italiano, che è il quinto, nell’Europa a 27, per percentuale di aziende individuali o familiari: il 93,5% secondo il dato Istat 2020. Tutto ciò è paradossale, se si pensa che sono numerosi i giovani che spingono per entrare in agricoltura, ma non possono disporre di una linea di successione familiare".
Quale può essere la soluzione?
"Oltre a porre condizioni che arginino la fuga dei giovani dalle zone rurali verso la città, così salvaguardando la continuità delle aziende familiari (e la non dispersione delle terre agricole), servirebbe strutturare una connessione fra gli agricoltori over 65, quelli che non possono contare su eredi, e giovani under 40 che non hanno alle spalle una famiglia agricola. Sarebbe stata la logica di una misura della Politica Agricola Comune (PAC) sulla cooperazione per il ricambio generazionale, che però non è stata attivata da nessuna regione italiana, a causa della sua complessità; mi risulta però che proprio la Regione Toscana sta tentando di recuperarne i principi ispiratori. Si potrebbe però sperimentare un mix fra la misura PAC sul primo insediamento, che elargisce un finanziamento ai giovani che vogliono avviare un’azienda agricola, e la normativa italiana sull’affiancamento, che invece prova a favorire il tutoraggio dell’anziano a beneficio del giovane. Lo scambio di risorse (energie e capitale freschi contro terra agricola e esperienza) potrebbe essere mutualmente vantaggioso e favorire il successivo passaggio dell’azienda e dei diritti sulla terra agricola".
Giorgio Peruzzi


