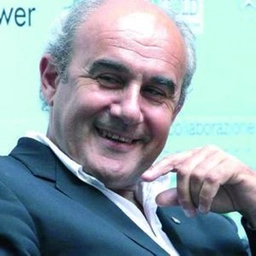Fra storia e leggenda, la processione ripecorre la strada che ripropone il tragitto che il Volto Santo compì per spostarsi dalla basilica al duomo .
Da S.Frediano al Duomo di S.Martino, un percorso breve in linea d’aria, un vorticoso giro per le vie più importanti della città, per rendere omaggio alla sua storia e ai centri del potere, è quello che da sempre ripercorre la Luminara della Santa Croce. La riproposizione del tragitto che il Volto Santo miracolosamente compì per spostarsi dalla sua prima "casa", la basilica di San Frediano, al duomo, il tempio dove ancora oggi si celebra il suo culto, in una casa più degna del suo rango, destinata ad ospitarlo in eterno.
Un percorso ricco di mistero, di storia e ancora di leggenda che ci ricorda come il Crocifisso, sparito più volte da S.Frediano, riapparve miracolosamente negli orti del vescovo di Lucca. E se, a prima vista, sembrava essere stata opera di burloni o malintenzionati, ai lucchesi, alla fine, apparve come una precisa volontà del Signore e lì vollero erigergli una prima chiesa, ancor prima di accoglierlo trionfalmente in duomo, forte del successo e della fama conquistata tra le migliaia di pellegrini che giungevano da ogni parte d’Europa per venerarlo, lungo il cammino verso Roma. Un successo che richiamò nei secoli ai suoi piedi anche imperatori, sovrani, Capi di stato e Papi per sottolinearne quanto fosse rispettato e conosciuto. Merito anche dei miracoli che gli sono stati attribuiti, salvando in punto di morte, un menestrello accusato di avergli rubato il sandalo d’oro (che oggi rimane ancorato al piede destro solo grazie ad un calice d’oro) e poi lo sfortunato mercante Giovanni di passaggio a Pietralunga in Umbria, accusato erroneamente di aver ucciso una persona che invece aveva provato a soccorrere e ormai pronto per essere passato alla "mannaia".
Miracoli che avevano fatto fiorire la devozione verso il simulacro dei lucchesi, oltre i confini della piccola repubblica e che quattro secoli dopo lo avrebbero fatto "eleggere" a furor di popolo, con tanto di cerimonia di incoronazione, il "Re dei lucchesi", per averli salvati ripetutamente da epidemie, guerre e catastrofi naturali. Divenne quindi una forma di riconoscenza prima di diventare un evento, il più sentito e partecipato, dello Stato lucchese, in cui furono ben miscelati gli aspetti religiosi e politici, tutto dettagliatamente descritto anche nello statuto comunale del 1308, in cui furono chiamati a sfilare tutto il clero di Lucca e tutta la rappresentanza politica e i cittadini di tutte le terre appartenenti allo stato lucchese. Un invito che per alcune comunità, quelle di confine, che diveniva un obbligo non gradito, un atto di sudditanza a cui nessuno poteva mancare, pena multe o addirittura il carcere. A sfilare per la prima parte della processione toccava alla rappresentanza religiosa, partendo dalle cariche minori fino ad arrivare al vescovo che precedeva il Crocifisso del Volto Santo, a seguire erano le massime cariche dello Stato, a partire dal gonfaloniere, poi sindaco della città, fino ai singoli paesi, ognuno con l’obbligo di sfilare con un cero, tanto più grande e costoso, quanto era la carica ricoperta o il numero delle persone residenti nei vari paesi. Una scia infinita di lumini in cui si consumava ogni 13 settembre il rito della Processione, per questo ribattezzata "Luminara", in cui il sacro si mescolava al profano e di cui oggi vediamo e apprezziamo soprattutto la parte folkloristica.