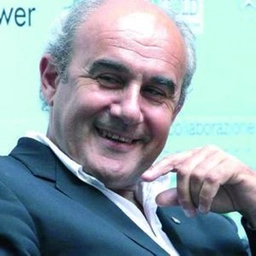Militari italiani a Rodi nel 1943
"L’esempio degli altri non ci ha scossi, le eloquenti perorazioni di amici e colleghi ci hanno lasciati al punto di partenza. E sì che tante persone ci hanno pregato di non fare sciocchezze, di non fare atti di eroismo che nessuno avrebbe ricompensato. Eppure non era possibile decidere quel ‘sì’. Si ribellava a ciò l’amor proprio offeso e la coscienza di un passo falso irrimediabile. Non per tutti la coscienza è cosa morta. In noi si è fatta sentire viva, eccome! All’estremo minuto è stato necessario decidere: ci siamo guardati negli occhi ancora esprimenti la più viva repulsione al ricatto, ed abbiamo firmato…". Così il tenente del Genio Arnaldo Manni scrive, nel marzo del 1944, nel suo diario "Bisogna andare a Rodi (1943-1945)", descrivendo la resa della propria coscienza. Non un atto di convinzione politica, ma la scelta disperata di sopravvivere e salvaguardare i propri cari. Una decisione che lo tormenterà per anni. Siamo nell’estate del 1943 quando Manni, originario di Castelfranco Emilia (a quel tempo in provincia di Bologna), viene destinato a Rodi, isola del Dodecaneso sotto occupazione italiana, ha ventisette anni. L’arrivo è umiliante: gli ufficiali accovacciati tra casse e valigie sugli autocarri, mentre i tedeschi osservano ironici. È l’immagine plastica di un prestigio ormai consunto. Poi l’8 settembre. L’armistizio annunciato da Badoglio che per molti significa la fine della guerra, per Manni è invece l’inizio del disastro: "Non ho il coraggio di condividere la gioia di molti (…) la più grande tragedia della storia italiana è giunta all’epilogo. Non sarà finita la guerra, no!". Infatti, due giorni dopo, Rodi cade sotto il controllo tedesco. Da quel momento comincia la spirale. Le autorità naziste pretendono l’adesione degli italiani alla Repubblica Sociale. L’ordine del generale Kleemann è perentorio: giurare fedeltà o affrontare deportazione e rappresaglie. Manni descrive la trappola con lucidità: "Dalla padella nella brace! O aderire, dando un sonnifero alla coscienza e rimanere al proprio posto (...), O non aderire e perdere l’impiego e lo stipendio, essere deportato in territorio non italiano in attesa di subire le rappresaglie, certo dure, del governo di Mussolini, o di apprendere le ritorsioni che il governo stesso potrebbe adottare nei riguardi delle famiglie in Patria (...). Che fare? Dopo sei mesi di minacce e notti insonni, ancora a questo punto siamo!". Il suo diario diventa un campo di battaglia interiore. L’amore per la moglie Didì e per il figlio lo spinge a firmare, la coscienza gli urla di resistere. L’8 marzo, compleanno della moglie, annota parole struggenti: "Caro mio amore, come vorrei esserti vicino per dirti tutto il grande, immenso affetto che ti porto. Ho offerto al Signore la Messa e la Comunione di stamattina per chiedergli protezione su di te e sul nostro bimbo". Il giorno dopo, però, il tempo delle preghiere è finito. I tedeschi stringono la morsa. Restare inflessibili significa rischiare la deportazione in Germania, forse la morte. Cedere vuol dire macchiarsi di un giuramento imposto. Alla fine la scelta: "Abbiamo firmato. Una resa che non è liberazione, ma condanna a un tormento silenzioso. Il diario di Arnaldo Manni restituisce la realtà di tanti ufficiali italiani dispersi nelle pagine dimenticate della guerra: uomini senza ordini, costretti a decidere da soli tra coscienza, onore e sopravvivenza. Non eroi, non traditori. Solo esseri umani in trappola. Quando nel 1945, dopo il suicidio di Hitler, arriva anche a Rodi la notizia della fine, la libertà non cancella le ferite. Manni tornerà a casa, ma il peso di quella firma rimarrà inciso nella memoria.