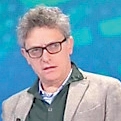Ci sono angoli della storia che rimangono in disparte, altriche la storia ha dipinto così come li ha percepiti una sentimentale storiografia di fine Ottocento che stenta, ancor oggi, ad esaurirsi. I giorni di Campaldino hanno polarizzato l’attenzione degli storici, come dei romanzieri venati da campanilismo o revanscismo, mentre gli eventi successivi alla battaglia, sono rimasti in sordina. E ciò è successo anche alla figura di Galasso da Montefeltro, podestà ghibellino di Arezzo per alcuni anni; poco noto, è stato dipinto come valoroso quanto spietato e nerboruto masnadiere nel romanzo “Clarice”, opera di Enrico Carboni morto nel 1885. Il romanzo è rimasto inedito sino ad oggi, avendo solo recentemente trovato l’edizione per i tipi de La Stamperia.
Gran parte della nomea di Galasso, etichettato da certa storiografia come l’ “impalatore”, proviene da un evento svoltosi nel 1298, drammatizzato nell’immaginario storico e collettivo riuscendo a tenere banco, per oltre un secolo, nelle serate senza tv nei paesi lungo la Marecchiese ai piedi di S.Leo; la stessa via che congiunge Sansepolcro a Rimini e dunque Arezzo al mare attraverso i territori di Badia Tedalda e dei Montefeltro.
Ma chi era Galasso da Secchiano, conte di Montefeltro? Fu Signore di Cesena, cugino di Guido, padre di Bonconte, cui successe come podestà in Arezzo dopo la battaglia di Campaldino, nel 1290; fu riconfermato in tale ufficio nel 1291 e 1298. Come ricordano gli Annali Aretini, “inter Castellanos et Arretinos tunc pax facta est”, Galasso si adoperò per stipulare la pace fra Arezzo e Città di Castello e per riconciliare guelfi e ghibellini aretini.
Il sedimentato legame politico delle forze ghibelline di Romagna con quelle aretine era diventato infatti lo zoccolo duro del ghibellinismo che non riuscì ad essere intaccato da qualsiasi iniziativa, militare o istituzionale, adottata dalla Chiesa; sono le mani di uomini delle terre transappenniniche o della Romagna toscana, quali i Montefeltro, i della Faggiuola o gli Ubaldini della Carda, che forgiano le direttrici politiche di Arezzo, gli stessi uomini che avevano dato prova di lealtà a Campaldino.
Galasso dette così l’avvio a quella rinomanza d’illuminato signore che impressionò Dante che lo dipinge come persona liberale lontana dalle avidità, che volle dominare non come tiranno, ma come funzionario eletto dal popolo. I recenti studi, promossi dalla Società degli Studi storici sul Montefeltro, raccolti negli Atti “Galasso da Secchiano, conte di Montefeltro”, ne delineano i reali contorni, secondo la documentazione e le gesta che lo riguardano. Il podestà aretino, che tenne le redini nel momento dell’exploit guelfo, figlio dei delicati equilibri politici negli scontri tra le fazioni filoimperiali e papali, appare “feroce come richiedevano i tempi, equilibrato come reclamavano quei popoli; misurata e proporzionata la sua condotta rispetto alle esigenze dei potenti, fossero papi, re o rettori, ma risoluta e spietata verso i ribelli. Astuzia, inganno e violenza, le insegne delle sue conquiste; prontezza e rapidità, gli attributi del suo comando; regolate e bilanciate le armi del suo potere.”
Un evento, forse storiograficamente esagerato, dovette macchiare la figura del Podestà di Arezzo, poi Podestà e Signore di Cesena. Nel 1298, l’8 di giugno, Corrado da Montefeltro, d’appartenenza filoghibellina, venne ucciso, a tradimento, da congiurati suoi fedeli unitamente al figlioletto, i fratelli Filippo e Giovanna: la moglie, Costanza, fu risparmiata e tenuta in carcere sotto osservazione affinchè, eventualmente incinta, non generasse un discendente.
Corrado era Signore di Pietrarubbia, una fortificazione, posta su una aspra roccia, costituita da un cassero e due torri, secondo la Descriptio del Cardinal Anglic a metà del Trecento. Tale massacro dovette derivare, quale ritorsione, dagli eventi guerreschi di alcuni giorni prima. Infatti secondo gli Annali Cesenati, il 20 di maggio, Galasso con i Cesenati e i collegati montefeltrani, ivi verosimilmente compreso Corrado, assediò la fortificazione di Piega, lungo il Marecchia presso Secchiano e San Leo. Bartolino Olivieri di Piega con il figlio vennero colpiti da crudelissima morte e così “affixos in palo”; perirono a fil spada anche altri fedeli degli Olivieri “inimici capitales” di Galasso. Una morte esemplare, quella di morire “affixos in palo”. Una modalità che valse a Galasso l’etichetta di “impalatore”, come sarebbe poi divenuto noto Vlad Tepes (Vlad III di Valacchia, Dracula), sebbene tale supplizio potesse indicare anche l’essere inchiodati al palo o attaccati, impiccati ed esposti, per rimanere in mostra a memoria della potenza di Galasso.
Il cronista bolognese Pietro Cantinelli genera comunque un dubbio, legittimo e sospetto. Qualora non si tratti di mero errore di data, il Chronicon pone la strage di Pietrarubbia al g20 di maggio, prima cioè che si compisse l’assedio di Piega (29 maggio). In tal caso, i pezzi sulla scacchiera, ed i relativi ruoli, verrebbero a ribaltarsi indicando una realtà ben diversa che potrebbe spiegare l’apparente efferatezza delle morti di Piega: Galasso avrebbe, lui sì, agito per ritorsione giustiziando, in modo plateale e significativo, i ribelli dei Montefeltro, “inimici capitales”, ad imperitura memoria nel gioco di equilibri che richiedevano i tempi. Potrebbe esserci riuscito se ancora oggi se ne parla.