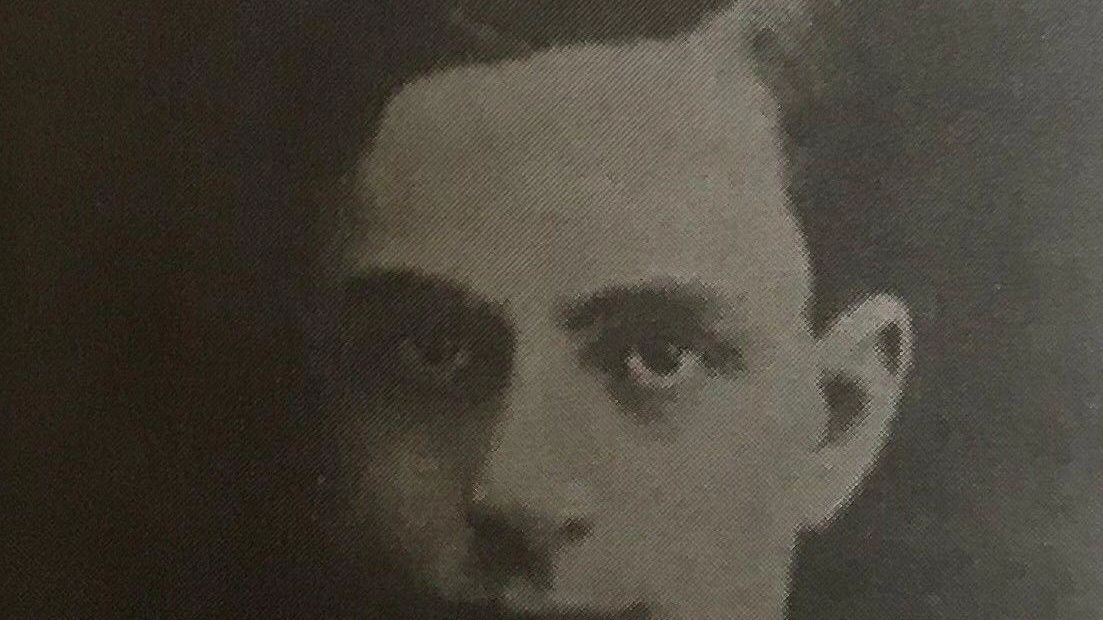
Il 7 aprile 1927, nel corso di una tornata solenne alla Casa del Petrarca, veniva conferita la cittadinanza aretina onoraria al patrizio cortonese e fiorentino Conte Giuseppe Fortunato Maria Passerini il quale, per quanto nato a Firenze nel 1858 (dove morirà nel 1932), doveva evidentemente possedere grandi meriti nei confronti della città del Petrarca.
Meriti che sono ben noti agli studiosi, anche per i saggi a lui dedicati dagli storici concittadini Franco Cristelli e Giulio Firpo, nonché per il convegno che l’Accademia Petrarca organizzò nel giugno del 2007, ma certamente poco o nulla noti al grande pubblico: assai opportunamente, dunque, la Brigata degli Amici dei Monumenti e la stessa Accademia Petrarca riaccendono, in vista dell’anno dantesco, i riflettori su questa singolare figura di letterato con la conferenza che il prof. Simone Allegria terrà domani alle 17,30 alla Casa del Petrarca sulla figura di questo "aretino ritrovato". Ma andiamo con ordine.
Appartenente ad una famiglia fiorentina con un ramo cortonese dal passato glorioso (basterebbe citare il suo membro più celebre, il potentissimo cardinale Silvio Passerini che introdusse il Vasari sedicenne alla corte medicea e volle a Cortona il Palazzone decorato dal Bernabei e dal Signorelli) il conte Passerini cominciò la sua carriera di studioso entrando come sottobibliotecario di quarta classe alla Biblioteca Nazionale di Firenze e la chiuse come bibliotecario capo della Biblioteca Medicea Laurenziana. Firmandosi Giuseppe Lando (nome che pare gli sia stato assegnato dal D’Annunzio del quale fu grande amico, estimatore e sodale) il conte si convinse che la cultura fosse il veicolo imprescindibile per la tenuta spirituale e morale della Nazione e individuò nello studio e nella divulgazione della Divina Commedia l’asse portante della sua attività culturale.
Nonostante fosse sostanzialmente un autodidatta (non conseguì alcuna laurea, come accadrà del resto a Quasimodo, Ungaretti e Montale) divenne ben presto un dantista di rilevanza internazionale, membro della Crusca e di prestigiose accademie europee, nonché fondatore di giornali e riviste di studi danteschi: a lui si deve la monumentale edizione della Divina Commedia, splendidamente illustrata, che l’editore Olschki pubblicò in occasione del cinquantenario dell’Unità d’Italia. Ma non solo di Dante ebbe ad occuparsi: a lui si debbono anche i vocabolari della poesia delle “Tre Corone”: Carducci, Pascoli e D’Annunzio, con un’appendice del vocabolario della prosa dannunziana.
La sua attività ebbe anche un risvolto politico: nazionalista e interventista, aderì nel 1920 al Fascismo e partecipò alla Marcia su Roma, ma la frequentazione del D’Annunzio lo tenne lontano da coinvolgimenti troppo marcati e la sua collaborazione fu di natura più che altro amministrativa, anche se nella sua splendidida villa cortonese ospitò alcuni esponenti dello squadrismo locale.
Ma torniamo ai meriti del Passerini nei confronti di Arezzo, che gli fruttarono la cittadinanza onoraria. Tutti sanno, anche per i recenti strascichi giudiziari non ancora sopiti, quale importanza rivesta l’Archivio Vasariano, conservato nella Casa Museo Vasari ed oggi interamente digitalizzato: ebbene, fu il Passerini a convincere, nel 1921, il conte fiorentino Luciano Rasponi Spinelli a cederlo in deposito perpetuo al Comune di Arezzo. Ed è appunto in forza delle clausole originali della cessione che questo importantissimo complesso di carte, fonte primaria per gli studi storico-artistici intorno al Rinascimento italiano per le informazioni che contiene sulle opere prodotte dal Vasari e sulle sue relazioni con i maggiori intellettuali ed artisti dell’epoca, pur rimanendo proprietà degli eredi del conte, non può in nessun caso uscire da Arezzo! E c’è di più, naturalmente. La passione, la competenza e un naturale talento investigativo, unitamente all’indispensabile disponibilità finanziaria, portarono il Passerini ad acquisire, anno dopo anno, un’immensa biblioteca dantesca, comprendente oltre cinquemila pezzi, fra monografie e numeri di riviste, inventariate e catalogate, con in più uno schedario con qualcosa come diecimila schede di appunti e annotazioni, senza contare tutti i manoscritti dei suoi studi danteschi e un archivio ricco di oltre ottomila lettere scambiate nell’arco di mezzo secolo con intellettuali e studiosi di Dante italiani e stranieri.
Ebbene, a legare definitivamente ad Arezzo il Passerini fu la donazione di tutto questo materiale all’Accademia Petrarca in deposito perpetuo per onorare la memoria del figlio Giulio Luigi, caduto ventiduenne sul Podgora nell’ottobre del 1915. Una curiosità. In una delle due xilografie del De Carolis in possesso dell’Accademia Petrarca, il “Dantes adriacus”, c’è la dedica del D’Annunzio nella quale il Cristelli ha notato uno strano segno che precede la firma autografa: una croce arricchita da quattro tratti, frecce o fiammelle. Lo studioso aretino ha ipotizzato che potrebbe essere questo un messaggio esoterico lanciato dal Vate al Passerini, rimandante forse ad un’appartenenza massonica: del resto massone era il Vate e tali erano anche Pascoli e Carducci, oggetto degli studi lessicali del nostro.

