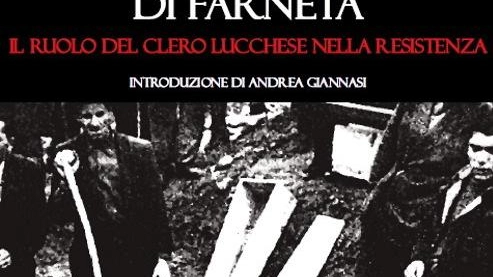
Il 2 settembre si ricorda a Lucca il rastrellamento della Certosa di Farneta, avvenuto nel 1944, che portò poi i prigionieri ad essere vittime di una serie di eccidi e fucilazioni. Riportiamo dal saggio “L’eccidio della Certosa di Farneta. Il ruolo del clero lucchese nella Resistenza” di Walter Ramacciotti, con prefazione storica di Andrea Giannasi, edito da Tralerighe libri, la parte dedicata ai tragici fatti con i soldati tedeschi
"Pochi giorni prima che Lucca fosse liberata, precisamente nella notte fra il 1° e il 2 settembre del 1944, alle ore ventitré e quindici solari (particolare da tenere presente), qualcuno suona al grande portone d’ingresso della Certosa di Farneta: si tratta di un sergente tedesco delle SS che da qualche tempo era accolto nel convento in qualità di visitatore e di amico, noto in particolare al Padre Maestro, Dom Pio Egger. Con un pretesto, e cioè, dicendo che deve consegnare una lettera al padre suo amico, riesce a farsi aprire il portone, nonostante l’ora tarda; ma non appena l’anziano fra Michele Nota, addetto alla portineria, ha aperto, la gran porta è spinta con violenza da altri tedeschi, che fanno irruzione in Certosa.
L’anziano religioso viene preso e tenuto immobilizzato sotto la minaccia delle armi. Si trattava di una pattuglia composta da una trentina di SS, molti dei quali giovanissimi, che armati anche di mitragliatrici pesanti, invadono il Monastero, bloccando gli accessi e i passaggi esterni ed interni. Certamente essi sapevano che nel Monastero avevano trovato rifugio, sfuggendo ai rastrellamenti, un centinaio di civili, in gran parte abitanti dei dintorni, che i frati certosini avevano sistemato in alcune delle loro celle, provvedendo anche al loro vitto.
Sembra che il loro piano fosse stato quello di sorprendere e arrestare tutta la Comunità già riunita, durante il Mattutino, poiché verso le ventitré, quando per molti è ora di andare a letto, i Certosini invece si alzano per pregare. Ma non sapendo che l’orario interno e liturgico continuava seguendo l’ora solare e non quella legale in vigore in quei mesi, la loro spedizione risultò anticipata, giungendo in pratica nella chiesa della Certosa prima della Comunità.
I Monaci, che nulla di tutto ciò ancora sapevano, né avevano udito, giunsero puntualmente in chiesa alle ventitré e quarantacinque e notarono che c’era qualcosa d’insolito nonostante il “gran silenzio” che si osserva in Certosa dopo Compieta. Si sentiva, infatti, nell’attiguo coro dei Fratelli, un vociare animato di più persone. Le cose si chiarirono, appena entrò nel coro quel sergente che si era spacciato per amico, seguito dagli altri: subito minaccia di fucilare immediatamente chi avesse parlato, gridato o fatto segni.
Nel frattempo il Padre Maestro, che conosceva la lingua tedesca, per cui poteva fare da interprete, sforzandosi di apparire calmo, disse ai confratelli di non impressionarsi, perché i tedeschi cercavano delle armi che in Certosa non c’erano; aggiunse che nessuno doveva parlare e che tutti insieme dovevano recarsi in una stanza presso la porta principale. Subito i tedeschi sospinsero tutti i monaci nella stanzetta che è a sinistra dell’ingresso principale della Certosa, mentre in quella di fronte, cioè nella sartoria, furono guardati a vista fino alla deportazione il Padre Priore e il Padre Maestro. Il numero dei presenti in quel piccolo spazio andava aumentando di continuo, perché non tutti si erano trovati in Chiesa, in quanto non tenuti o dispensati per motivi di salute. I tedeschi li svegliarono in malo modo nelle loro camere, dando loro appena il tempo di vestirsi: li spingevano giù nella medesima stanza, dove tutti erano costretti a rimanere in piedi, immobili, ormai quasi stretti.
Ad un certo punto si sentirono alcuni colpi d’arma da fuoco e qualcuno lamentarsi a poca distanza. Il Padre Vicario si fece avanti verso la sentinella e gli disse che se c’era qualche moribondo voleva assisterlo; ma il soldato assicurò che non c’era nulla di grave. Quando i tedeschi furono sicuri che tutti i religiosi fossero in mano loro, e che nessuno di quelli messi sotto custodia sarebbe fuggito, andarono a caccia degli altri, ossia dei civili rifugiati che si trovavano in Certosa. Scovatili, li ammassarono come carne da macello presso la foresteria. Il sergente che guidava il drappello delle SS era furioso, perché i civili non erano pronti ad aprire la porta del luogo dove si trovavano, e con un fare di disprezzo, chiamava tutti “cani”, ordinando ai soldati di fucilare chiunque opponesse resistenza, tanto più che nel mezzo del cortile, verso il lato della porta, era piazzata una mitragliatrice pesante, puntata verso gli edifici interni.
Uno dei civili superstiti scrive: ‘Tutti gli arrestati furono frugati, derubati e tolti i documenti, e disposti lungo la foresteria, fino alla partenza”.
Il Padre Procuratore, che suo malgrado era costretto a seguire i tedeschi, aprire, mostrare loro ogni cosa e consegnare le chiavi, quando più tardi fu prigioniero con gli altri a Nocchi, ha riferito quanto quella furia delle SS diceva e faceva nel dare la caccia all’uomo; ha riferito anche però che alcuni rifugiati riuscirono a salvarsi, fuggendo: alcuni saltarono dalla finestra e anche altri si gettarono da parecchi metri, e altri ancora cercarono di scavalcare le mura di cinta. Purtroppo un gruppo di questi fu ripreso e pagò caro il tentativo di fuga. Una quindicina di uomini, tuttavia, riuscirono a mettersi in salvo attraverso un fosso o canale seminterrato, sollevando tutti insieme la pesante griglia di ferro che lo chiudeva.
Sappiamo anche che qualcun altro si salvò restando immobile in qualche nascondiglio; uno per esempio fra certi quadri accatastati, un altro sotto un pagliericcio, un altro ancora, in una specie di soffitta. Al mattino, la Comunità religiosa fu trasferita nella Cappella di Famiglia, dov’ebbe un po’ più di libertà e di respiro. I tedeschi dovevano essere ormai convinti che non avevano da temere la minima opposizione armata. In quella Cappella, il silenzio assoluto imposto dagli invasori non fu più così rigoroso, tanto è vero che permisero ai monaci sacerdoti di celebrare, uno dopo l’altro alcune Messe, non essendoci ancora la possibilità delle concelebrazioni. Per alcuni di loro, quella Messa fu l’ultima della loro vita.
Quasi al termine delle celebrazioni, rientrò il solito sergente, il quale intimò che uscissero subito alcuni, fra cui Lippi Francesconi e Muraglia che purtroppo erano stati riconosciuti e disse loro: “Sapete quel che vi aspetta!”. Poco dopo, sia loro, sia una quantità d’altri rifugiati, e con essi il Padre Priore e il Padre Maestro e alcuni religiosi già in abito civile, furono stipati in due autocarri coperti, con sentinelle armate su ogni sponda, e deportati a Nocchi, località nei pressi di Camaiore.
Fu portata via anche una povera donna, che a quanto si seppe poi, era la domestica di un parroco dei dintorni. Ignara dell’invasione, si era presentata quella mattina alla porta della Certosa con una lettera. Sembra che questa fosse indirizzata “Al rappresentante di macchine per scrivere”, appellativo sotto il quale si nascondeva uno di quelli che più accanitamente ricercavano. Fuori della porta era pronto un camion.
Il viaggio non fu lungo, ma con quell’autocarro militare traballante su strade accidentate, fu piuttosto penoso per qualche anziano, perché era chiuso da teli, e non era permesso sporgersi fuori, con sentinelle bene armate e guardinghe, soltanto chi era molto pratico di quelle strade poté riconoscere quale fosse il tragitto. Giunsero a Nocchi di Camaiore e furono rinchiusi in uno stanzone di un vecchio edificio rustico, ubicato al termine del caseggiato del paese, a pochi passi dal giardino dell’antica Villa Graziani, allora occupata dal comando e sede del tribunale tedesco dopo l’otto settembre 1943".

