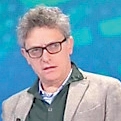Sotterranei di Fraternita
Arezzo 31 gennaio 2020 - E’ come appeso in alto alla parete, come un quadro. C’è un camino sospeso, annerito dall’uso e dal fuoco, porta lo stemma di Fraternita.Poco sotto una cucina a carbone e un acquaio di pietra. Come se il tempo si fosse fermato cinquecento anni fa, quando in quella stanza c’era ancora il pavimento. E’ un percorso di pietra arenaria, di secoli sovrapposti, di volte a crociera e archi, scale, finestre murate, aperture che conducono in Pieve o fanno intravedere un armadio di sacrestia, pozzi per acqua o grano, quello che conduce nelle viscere del Palazzo di Fraternita e che, forse, univa Corso, via Vasari e Piazza Grande. Sì, proprio come un corridoio vasariano, perchè quando quelle stanze sono state utilizzate per distribuire il grano alle famiglie povere della città l’artista era ancora vivo.
I sotterranei di Fraternita sono stati aperti per la prima volta per annunciare il progetto voluto dal rettore Pier Luigi Rossi e redatto dallo studio dell’ingegner Luigi Lucherini per la creazione di una pinacoteca di 700 metri quadrati dove raccogliere tutte le opere dell’ente. E soprattutto rileggere cinquecento anni di storia. “Un palazzo che è il cuore pulsante della storia culturale aretina, vocato a contenere i tesori della città, il museo dell’oro che ospiterà anche la mostra ‘Oro d’autore’ acquisita dalla Regione Toscana, il conservatorio della scuola di musica di Fiesole” dice convinto il sindaco Ghinelli. Si parte dalle stanze del grano dove è stato trovato un affresco che Tommaso Sensini sta restaurando con gli studenti dell’Itis per il programma di scuola-lavoro. Raffigura la Madonna della Misericordia con i Santi Lorentino e Pergentino e un religioso in primo piano: “Ha una veste bianca e un mantello con il simbolo Fraternita, forse l’arciprete della Pieve” spiega la rettrice Daniela Galoppi.
Ma con sorpresa. Durante la ripulitura è apparso il palazzo di Piazza Grande senza campanile, che Vasari stava progettando, né orologio, consegnato nel 1552: “Avevamo collocato l’affresco tra Cinquecento e Seicento, ora dobbiamo tornare almeno al 1550, sicuramente di scuola vasariana” fa sapere Sensini. Saranno le ricerche di archivio a svelarne l’autore.
“Qui veniva distribuito il grano e per richiamare gli aretini veniva suonata una campana del 1321, quella piccola che ancora oggi suona il quarto d’ora - spiega Rossi - qui si sovrappongo secoli di storia etrusca, romana, medievale, su un muro è incisa la data 1838, un collegamento sotterraneo, forse abitazioni, che ora vanno riempiti di attività”. L’agibilità è nel progetto dell’ingegner Lucherini: “La ricostruzione deve essere rigorosa per tornare al manufatto originale. Il problema più grosso è l’abbattimento delle barriere per un uso museale, va salvata la pavimentazione attuale, superati dislivelli e scalini, recuperate le vecchie aperture, creato un collegamento con i locali sotto la terrazza di Piazza Grande e al più presto un progetto esecutivo per salvare un esempio di architettura medievale”.