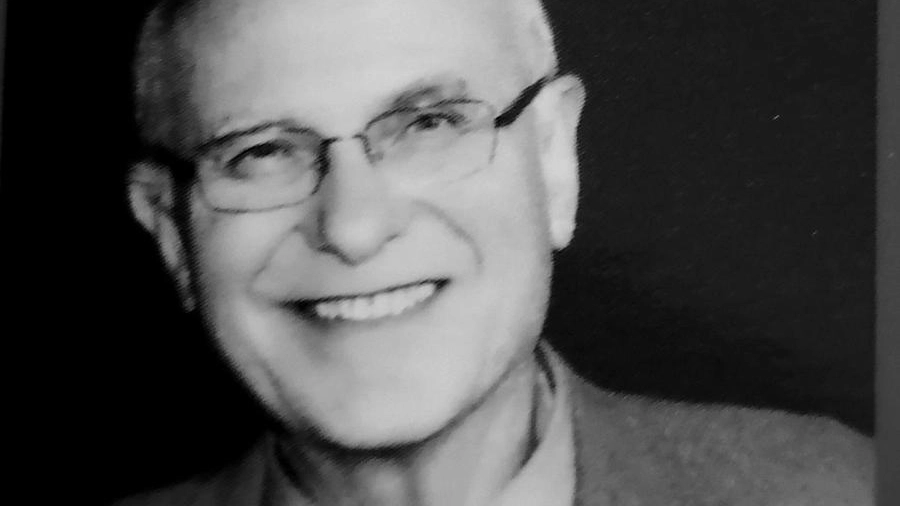
di Claudio Santori
È stato più volte notato lo squallore della periferia industriale di Arezzo, quale risulta ai forestieri (noi aretini abbiamo da tempo metabolizzato il rospo) che vengono dall’autostrada. E più volte questi viaggiatori si son sentiti riavere (e l’hanno scritto) quando si è imposta con serena prepotenza ai loro occhi la macchia arancione e verde su sfondo nero dell’imponente, e pur leggiadro edificio delle Grafiche Badiali. Un complesso architettonico che è entrato d’autorità nell’immagine ideale che gli Aretini hanno della loro città, insieme con la Piazza Grande e il campanile della Cattedrale.
Se la scelta del sito è stata un’idea geniale di Vittorio Badiali, la non meno geniale realizzazione dell’edificio, divenuto da subito il biglietto da visita della città, si deve al talento divinatorio di Giulio Rupi, l’ingegnere recentemente scomparso, strutturista puro, sempre proiettato verso il nuovo, tanto da lasciare in Arezzo una traccia indelebile con la Tortaia, la Meridiana, il Gruppo Graziella e il Palazzo commissionatogli da Piero Iacomoni per Monnalisa. Ma questo lo sanno tutti. Quello che invece sanno quasi soltanto i soci del Rotary Club Arezzo Est, di cui è stato presidente, quelli dell’ Accademia Petrarca, di cui è stato vicepresidente, e pochi altri è che non ha mai cessato durante tutta la sua vita di scrivere non soltanto, come era naturale, di argomenti di architettura, ma anche, e direi soprattutto di varia umanità.
Ed è appunto il libro che raccoglie una vasta scelta dei suoi scritti, appena giunto nelle librerie (L’uomo al quinto piano non ha più radici, Edizione Helicon, 318 pagg, Euro 15) a consacrarlo come un saggio, umoroso e stimolante maître à penser. Il libro, voluto dall’ Accademia Petrarca e prefato dal Presidente dell’Ordine degli Ingegneri, Carlo Biagini, con contributi di Giulio Firpo, Alberto Nocentini e Pietro Pagliardini, comprende scritti sull’architettura e l’urbanistica, apologhi e contrasti dialettici, saggi di etica, economia e sociologia, nonché una serie di a firma del suo eteronomo Aristarco de Pinolis e perfino micidiali aforismi (uno per tutti: “Si legge il giornale per sapere cosa hanno scritto i giornali”).
Sostenitore della città orizzontale contro la verticalità della filosofia dei grattacieli, fa dire al suo eteronomo: “I rapporti, le relazioni fisiche orizzontali che costituiscono nel tessuto urbano storico il senso della comunità non si possono realizzare in verticale all’interno di un grattacielo”. Magnifica utopia di un “umanista prestato alla tecnica” che ha alternato per tutta la vita filosofi e poeti col regolo calcolatore, fornendo un contributo determinante al modello di residenza delle Cooperative ACLI, opponendosi alla logica mortificante del “casermone” in nome di un’idea di abitazioni più umane, di due o tre piani, dove, come sottolinea Biagini, “il rapporto con la natura fosse presente, vuoi in forma di giardino privato che come verde in comune per tutti gli alloggi”. Il tutto pervaso da un discreto, ma deciso, rumore di fondo: la difesa appassionata e intelligente della civiltà occidentale. Il pezzo clou del libro è “Occidente patria mia”, composto di getto dopo l’assalto alle Torri Gemelle e rielaborato più volte negli anni seguenti.

