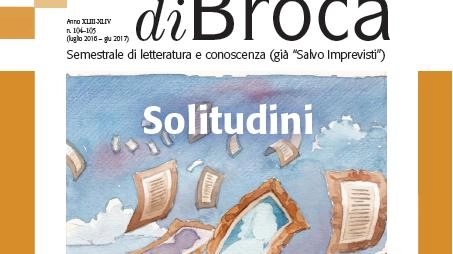
La copertina del nuovo numero de 'L'area di Broca'
Firenze, 15 maggio 2018 - Appartarsi o isolarsi, avere bisogno di una pausa oppure andare alla deriva. I significati della solitudine sono diversi e il nuovo numero de 'L'area di Broca', la rivista fiorentina diretta da Mariella Bettarini affida a 39 tra narratori e poeti la declinazione delle 'Solitudini', presentando anche due preziosi inediti di Gabriella Maleti, scomparsa nel 2016. Le due liriche risalgono all'anno precedente. La prima: “Chi respira e tace,/ poi solleva gli occhi e fissa/ davanti a sé. Guarda./ Ma davanti ha solo/ l’integrità di una soluzione./ Rimaneggiare quanto resta,/ che è ciò che ha sempre/ avuto:/ solitudo/ massima,/ benché tutto fosse/ vita”. La seconda: “Un raro fiore e pur/ comune s’intravede/ sul tetto di fronte./ Qualcosa di giallo chiaro/ sui coppi mattone,/ nella solitudine del tetto”. La solitudine di Gabriella Maleti è l'effetto di una lunga ferita che lascia spazio a un fiore che si intravede dalla finestra.
Vi sono alcuni filoni che l'esplorazione condotta dagli autori propone. Partiamo dall'idea della solitudine come appartarsi, necessaria per generare scrittura (Alessandro Franci) e per ritrovarsi con se stessi (Alice Sturiale).. Francesca Anselmi lo specifica come constatazione di essere tutti, da una parte, “isole nella solitudine dei mari” e ricercare “uno stato di quiete” che è “un ascoltarsi dentro”. Con due brevi prose Silvia Batisti ritrae nel riposo nottunrno e nella stanza chi porta in sé le presenze ospitate in chi dorme o si apparta. La solitudine è “necessaria” per Davide Puccini: “L'aspirazione alla solitidune o al contrario l'incapacità di sopportarla sono i movimenti di sistole e diastole che scandiscono il battito del nostro animo nella sua perenne incontentabilità: il cuore stesso della vita”.
Si affianca a questo significato di solitudine, quella del monaco e del profeta che però parla al cuore degli altri: Gabriella Fiori ne scrive a proposito di Antonella Lumini e Paolo Pettinari in un bel saggio proprio sulla solitudine dei profeti. Il secondo filone è quello della solitudine come dimezzamento. Nella poesia di Leopoldo Attolico la solitudine è la metà dell'altro che non riusciamo a indovinare ed è anche l'uomo dimezzato come descritto da Aldo Roda nelle sue 'Misure di spazio'. Annalisa Comes descrive la solitudine come ferita e come rimorso attraverso l'immagine della lama e della spina, mentre Loretto Mattonai individua il dimezzamento come “il mani nominarsi”. Per Roberto Maggiani sentirsi a metà è una componente fisica (i “solitoni”), è un bisogno di sole nella 'Poesia della pianta' di Giampiero Stefanoni. Massimo Seriacopi declina in una bella poesia la solitudine del dimezzamento come mancanza dell'altro in 'Partenze': “Ti sentivo, sentivo il tuo lamento,/ un canto verso il cielo di cobalto,/ d'organza un arabesco a giro lento,/ un inno melodioso, tenue assalto./ Era la luce a golfo frastagliato,/ era il rimpianto di ciò che era stato,/ un picchiettio di stelle, anima sola,/ agglutinato a groppo nella gola./ Era un pensiero: te ne stavi andando,/ e io che non potevo trattenerti./ Avrei voluto soprattutto averti./ Ma il mondo non confina col mio corpo,/ e non finisce con le mie esigenze./ E resto tra le tue partenze.” E la solitudine può essere vinta, come scrive Luciano Utrini: “Osa per dono/ isolate carezze/ tu non sei solo”. Vi sono solitudini oggettive. Mariella Bettarini le declina per arrivare a dire che si è “soli sinché...” non si riesce ad uscire di sé o fino a quando non si è accolti (l'abbandono dei migranti in mare). Questa attesa è raccolta anche da Annalisa Macchia in 'Tremo'. Oggettiva è la solitudine di una famiglia che vive di orfananze e che rigetta, attraverso la punizione, la vita di un ragazzo: è nel racconto di Giuliano Brenna, 'L'Orfanotrofio'. Brenna individua una radice precisa della solitudine, come rifiuto di amare, nella figura di un padre che “non aveva stabilito regole, perché il solo fatto di pensarle avrebbe significato prendere in considerazione l'altro, attribuirgli una presenza che non si riteneva possibile o tollerabile”. Per Carmen Grattacaso questo tipo di solitudine-abbandono ha il volto di chi è stato tradito da un'attesa affettiva; in Luca Saracino è “La mia famiglia” rovinata da un padre che gioca le risorse. Maria Grazia Cabras descrive la solitudine naturale dell'inverno e degli inverni, laddove gli alberi “abitanti di luoghi non più remoti” sono figura di persone in momenti di smarrimento, quando le forze vanno via. Questi stessi alberi sono anche nella mente di Carmela Pedone, che li sente finalmente potati. Maria Paola Canozzi descrive la solitudine come incapacità di costruire rapporti veri o duraturi: non è un giudizio ma è il ritrarre, con compassione, l'effetto di un'incapacità in un sessantenne col parrucchino, un mite impiegato contabile, un anziano vedovo di buon carattere, uno scontroso intellettuale e un meccanico dal sorriso buono. Roberto Mosi declina in versi la solitudine della città, come non luogo percorso da un cavaliere solitari. In Giovanni Stefano Savino, infine, la solitudine oggettiva è quella degli anziani. Ed ecco l'apparente solitudine degli addii che sono un arrivederci, come nel caso di Ilia di Marco sulla madre. Rossella Lisi riflette sulla compagnia degli animali e poi entra nella prosa di “Un sentiero solitario”, storia di una sorta di passaggio di testimone tra Francesca e Monica che ha perso un bambino in. La solitudine come timore del disfacimento e come fuga trova eco nelle 'Rimanenze' di Alessandro Ghignoli, in Liliana Ugolini (“il volto somiglia davvero a ciò che non volevo”) , al tentativo operato da Enrico Zoi di riaprire il varco dopo avere errato
Troviamo nell'Area di Broca la solitudine come finzione letteraria. Massimo Acciai Baggiani, conduce il lettore in una sorta di un 'Diario di un pazzo', dalla stesura gogoliana: il pazzo, tal Luciano Lalli che scrive il 10-11 vendemmiaio 224, intravede una verità oltre sé. In questo filone rientrano le solitudini del mistero di sei racconti di Maria Pia Moschini, percorsi da un'ironia che fa sperare. Antonella Pierangeli si lancia efficacemente nell' 'Autobiografia di un fegato', mentre Alessandro Salvi si identifica un “custode notturno” che ascolta i silenzi come pagine di una lettera il cui argomento è del tutto ignoto. Non poteva mancare la solitudine come morte e come assenza: Luciano Valentini nella sua poesia parla della solitudine come rendersi conto “di non avere un centro”, poi lo trova nella rievocazione dell'amicizia nel volto del poeta Attilio Lolini. Dai 'Sei piccoli scritti' di Maria Pia Moschini proponiamo 'Giardino': “Quando fu operato agli occhi rivide il mondo qual era. Definito. Perfetto. Notò allora la macchia d’umido sul muro del salottino, sfrangiata come una foglia di platano. La toccò delicatamente seguendone i contorni... Prima il dito indice, poi tutta la mano vennero assorbiti dall’immagine e Franz toccò il tronco di un albero fantasma. Aveva sempre desiderato un giardino”. Il nuovo numero dell'Area di Broca si può scaricare all'indirizzo http://www.emt.it/broca/broca105/broca105.pdf Michele Brancale

