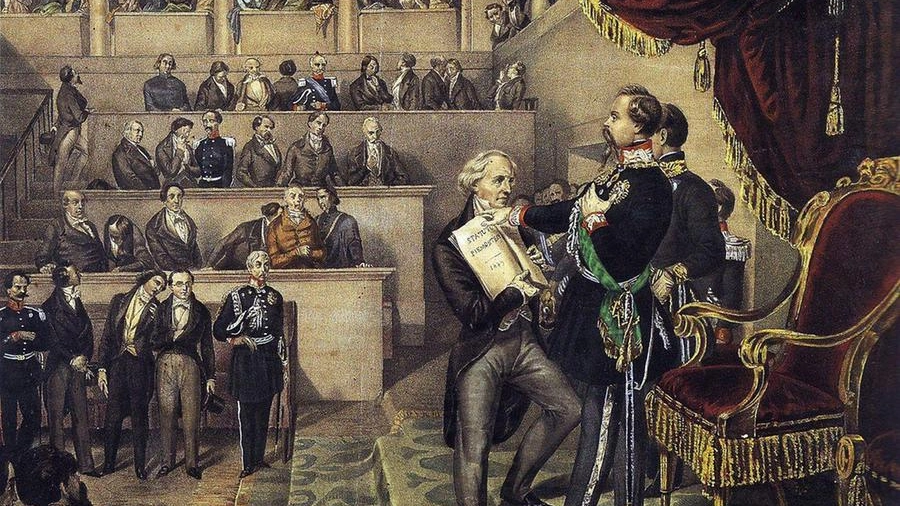
Liletta
Fornasari
Sorta nel diciannovesimo secolo e completamente dedicata all’arte allora contemporanea è stata la collezione del senatore aretino Leonardo Romanelli, figura politica di grande spessore, patriota di stampo moderato, fervente cattolico, amante della patria, della famiglia e della pittura dei giovani, oltre che grande conoscitore della lingua e della letteratura inglese. Negli ultimi anni della sua vita si dedicò alla sua preziosa raccolta, aiutato negli acquisti dagli stessi artisti, divenuti in alcuni casi suoi intimi amici.
Proprio questi furono talora responsabili di alcuni donativi fatti al senatore. Il senatore stesso, deluso e amareggiato per le tante disavventure politiche e per i dispiaceri familiari, scriveva che solo gli artisti dimostravano di essere amici sinceri e duraturi. Ea nato a Quarata il 7 gennaio del 1803 da Lorenzo Romanelli e da Luisa Tavanti. A undici anni l’ingresso nel seminario di Arezzo dove rimase fino al 1819, quando si trasferì a Pisa per iscriversi alla facoltà di Giurisprudenza. Usufruendo nel 1821 di un sussidio erogato dalla Fraternita dei Laici, si "addottorò" nel 1826, dopo essere stato espulso da tutte le università del Granducato toscano a seguito di alcuni tafferugli avvenuti nel 1823 - coinvolgendo anche Francesco Domenico Guerrazzi - e dopo essere stato riammesso nel 1825.
Tornato ad Arezzo esercitò il mestiere di procuratore, senza mai raggiungere il titolo di avvocato, a causa di "urgenze "determinate dalla morte del padre, dal matrimonio nel 1828 con Anna Fracassi e dalla nascita tra il 1828 e il 1830 dei suoi tre figli. Il suo secondogenito morì di tisi a 28 anni e anche la figlia, fattasi suora vincenziana, morì trentenne.
Rimandando agli studi di Alessandro Garofoli relativamente alla figura politica, e a quelli di Ersilia Agnolucci e di chi scrive sulla figura di collezionista, è interessante ricordare che fu mandato in esilio nel 1849 con l’accusa di lesa maestà, tornato in patria dopo quattro anni di prigionia.
Durante il periodo trascorso in carcere, in gran parte alle Murate, stese le Memorie a difesa del suo operato. Romanelli non abbracciò mai il pensiero mazziniano, ricoprendo molte cariche pubbliche. Fu presidente della Società Operaia e un anno dopo le grandi manifestazioni fatte in onore di Guido Monaco, nel 1883 fu eletto senatore.
Per l’Arezzo post unitaria era un momento di grandi dibattiti anche politici. Il senatore, fedele fino in fondo al pensiero di destra, da lui giudicato tradito, ormai avanti con l’età e malato, visse l’ultimo periodo della sua vita rifugiandosi nella passione per l’arte e per il collezionismo di matrice liberale, probabilmente orientato dal suo amico livornese, nonché compagno d studi e di goliardie a Pisa, il già ricordato Guerrazzi, autore di celebri romanzi patriottici di stampo romantico, oltre che critico d’arte.
Dagli anni Sessanta dell’Ottocento casa Romanelli in via Cavour 35, sia per gli aretini, sia per i forestieri, fu un luogo di incontri culturali e politici. La sua ricca collezione, sistemata in un corridoio e in alcune stanze, venne ammirata anche da Vittorio Emanuele quando nel 1861 fece visita in città. Erano amici di Romanelli gli artisti Antonio Puccinelli, Amos Cassioli, Stefano Ussi, il restauratore Gaspero Bonci e lo scultore aretino Luigi Gatteschi. Quest’ultimo, conservatore dell’Istituto Bartolini e professore della Scuola Libera del Disegno e della Modellatura, istituita dalla Fraternita fu un vero habituè di casa Romanelli.
Nonostante la stretta relazione intercorsa tra i due, la collezione annovera dell’artista solo una scultura raffigurante un San Michele. Proprio a Gatteschi il senatore avrebbe dato l’incarico di fare il monumento del figlio Orlando nel cimitero monumentale cittadino. Ad Arturo Romanelli, bisnipote di Leonardo, spetta il merito di avere tentato di ricomporre la collezione, individuando tra i vari rami degli eredi i dipinti appartenenti al nucleo originario.
Tre gli inventari che hanno reso possibile la ricostruzione dei momenti e dei tempi degli acquisti. Il primo è quello redatto dal senatore stesso nel 1876, il secondo è una bozza manoscritta privata, successiva all’inventario pubblicato da Pasqui e da Viviani nel 1925 e relativa al nucleo più consistente tra quelli rintracciati dopo la dispersione determinata dalle divisioni ereditarie, subito dopo la morte del nipote Orlando Gabriele.
Tornando agli artisti amici del senatore, l’amicizia con Puccinelli, professore di disegno a Firenze, risale al 1857. Puccinelli eseguì per il senatore alcuni ritrattimolto cari. Uno quello che fissa il profilo accanto alla figlia suora. L’altro è l’immagine del secondogenito Orlando, prematuramente scomparso e con il quale il senatore aveva avuto contrasti a causa di Cesira Borri, la donna che il giovane aveva voluto sposare. E infine quella del primogenito Lorenzo con la moglie Gabriella Poulanes Belot, destinata a morire dopo avere dato alla luce il figlio Orlando Gabriele, per tutti Gabriello.
A questo triste episodio si lega il quadro di Amos Cassioli con l’Anima della madre che scende sul figlio (collezione privata). Il senatore si era molto risentito anche della scelta di Sofia di farsi suora. In una lettera al Guerrazzi era irritato dall’offesa che la figlia faceva allontanandosi dalla famiglia. Nella collezione a questo evento familiare doveva collegarsi il dipinto "Mondo perduto" di Lanfredini, ispirato alla vita claustrale. Nella presentazione del catalogo da lui stesso compilato nel 1876, Leonardo Romanelli, spiegando le ragioni delle proprie scelte e le finalità della ccolta, elencava i nomi degli artisti presenti in collezione compiacendosi di avere acquistato qualche tela dei contemporanei meglio distintisi nella Scuola Toscana.
Tra questi Pietro Benvenuti, Vincenzo Chialli, Giuseppe Bezzuoli, Antonio Ciseri e molti altri. Dal confronto con gli inventari risulta chiaro come alcune acquisizioni siano state successive al 1876, probabilmente fatte dallo stesso nipote Gabriello, cresciuto sotto la guida del nonno.

