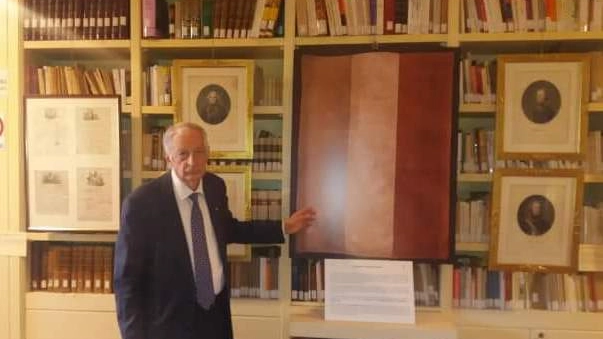
Cosimo Ceccuti, presidente Fondazione Spadolini Nuova Antologia
Firenze, 25 marzo 2020 - La Fondazione Spadolini Nuova Antologia celebra il Dantedì con una serie di appuntamenti che si concluderanno il 2 giugno, festa della Repubblica. In tempi di Coronavirus e limitazione delle libertà individuali e collettive, che si ripercuotono sulla possibilità da parte delle organizzazioni culturali di organizzare eventi pubblici, la Fondazione presieduta da Cosimo Ceccuti ha deciso di presentare una serie di interventi capaci di richiamare l'attenzione dei lettori sul significato storico di date, eventi e figure legati a ricorrenze nazionali del I e del II Risorgimento. L’intento, spiega Cosimo Ceccuti: “È quello di trarre dalla conoscenza del passato la forza per ripartire”.
Nello specifico saranno scritti articoli di richiamo storico, presentati al pubblico attraverso i canali social della Fondazione, in occasione delle seguenti date: il 25 marzo “La giornata di Dante, padre della Nazione”; il 25 aprile “La Liberazione”; il 27 aprile “Firenze e la fine del Granducato” (1859, la cacciata del Granduca); il 29 maggio “Ferdinando Zannetti, il medico eroe di Curtatone” (Anniversario di Curtatone); il 2 giugno: “Festa della Repubblica”. I lettori potranno accedere ai contenuti attraverso la pagina Facebook della Fondazione, community Nuova Antologia, e dal sito www.nuovaantologia.it.
Questo il primo intervento di Cosimo Ceccuti dal titolo ‘Dante simbolo della Nazione’: “All’indomani del Congresso di Vienna, nel clima pre-risorgimentale che accompagna la stagione del romanticismo, la figura e l’opera di Dante Alighieri assunsero accanto a una connotazione puramente letteraria quella politicamente rilevante di simbolo dell’identità nazionale, di cui Giuseppe Mazzini fu il maggiore profeta. L’Italia, allora divisa in otto Stati, non si era mai costituita come la Francia in uno Stato unitario, ma – fu questa la grande intuizione del giovanissimo Mazzini – era stata ed era una nazione, ovvero una comunità con una propria, specifica identità culturale, civile, religiosa. Non era lontano dal vero il poeta Alphonse de Lamartine, – innamorato del nostro Paese –, definiva l’Italia “terra di morti”, all’inizio degli anni Venti, e ciò gli valse una sfida a duello. Eppure… Dai potentati, che a Vienna ridisegnavano l’Europa, Venezia – la più celebre delle Repubbliche marinare, con tre secoli di storia – fu cancellata dalla Carta geo-politica per essere inserita nel Regno Lombardo-Veneto, sotto l’egemonia austriaca. Genova, altra gloriosa Repubblica marinara, perse allora la sua autonomia entrando a far parte del Regno di Sardegna. Ebbene, come reagirono le popolazioni delle due ex-Repubbliche? Scesero forse in piazza, dettero vita alla rivoluzione? Niente di tutto questo. Si limitarono a prendere atto del “nuovo padrone”. Mancava una coscienza nazionale, la consapevolezza, l’emozione e l’orgoglio di una comune appartenenza, lo stesso amore per la libertà. Sarà una lenta, graduale conquista, comune a numerose nazioni europee, dall’Italia alla Polonia, dalla Germania all’Ungheria. Una conquista che si avvarrà innanzitutto della cultura. L’editoria, che allarga il bacino degli utenti, sensibilizzerà le classi dirigenti, in grado di leggere, col filone del romanzo storico, di crescente, straordinario successo. Nella “terra di morti”, nel corso dei secoli, c’erano pure stati momenti di reazione, di vitalità, di non rassegnazione alla volontà delle prepotenze straniere, con singoli gesti di dignità e di libertà. Ecco le figure di Ettore Fieramosca, protagonista della “disfida di Barletta”, di Francesco Ferrucci, eroico difensore della Repubblica fiorentina del 1530, ecco i “Vespri siciliani”… Per le masse analfabete la stessa funzione l’avrebbe svolta il teatro, la tragedia (si pensi all’Arnaldo da Brescia di Giambattista Niccolini) e il melodramma, le opere quali il Nabucco e I Lombardi alla prima crociata di Giuseppe Verdi, della prima metà degli anni Quaranta. Sul piano politico irrompe la tenace, irriducibile propaganda di Giuseppe Mazzini che nel 1831 dà vita alla Giovine Italia e nel 1834 alla Giovine Europa: la nazione e la confederazione delle nazioni, che tendevano a divenire Stati, liberi ed eguali. Profeta della rivoluzione delle coscienze prima ancora del succedersi delle agitazioni, Mazzini esalterà Dante quale padre dell’Italia libera ed una. Il Poeta non è dunque solo il simbolo dell’unità della lingua, ma della nazione. La nuova interpretazione viene affrontata su due periodici, a cavallo degli anni Venti, a fianco dei numerosi articoli che si soffermano sugli aspetti letterari: il milanese Conciliatore (1818-1819) e la fiorentina Antologia (1821-1832) entrambi, non a caso, soppressi dall’autorità austriaca. Nelle pagine del Conciliatore emerge la figura di Giovanni Berchet, che si firma con lo pseudonomo di “Grisostomo”. Commentando il 12 novembre 1818 la Storia della poesia di Bouterwek, l’autore sottolineava in un confronto compartivo come la poesia italiana fosse nazionale, tesa a respingere i canoni per così dire universali (classicismo) per ispirarsi alla realtà del suo tempo. «Il Poeta ottiene il fine più sublime e più vero dell’arte – cito Berchet – quando tiene conto del carattere della sua nazione e del suo secolo e non lo ributta sdegnosamente come inopportuno a’ suoi intendimenti poetici. La poesia de’ poeti sommi d’Italia, è poesia nazionale nello spirito del secolo in cui essi vivevano». Il 27 dicembre Berchet intervenne per rintuzzare le accuse di Federigo Schlegel, al Sommo Poeta ribadite da H. Hallam, per eccessiva ira verso la patria: accuse già confutate da Ugo Foscolo. «Dante amava la sua patria più che chiunque – è la perentoria replica degli amici del Conciliatore – ma ne odiava i delitti. E chi ama la patria davvero s’irrita delle turpitudini de’ suoi concittadini: e mentre che il vile adulatore blandisce il vizio che trionfa, l’onest’uomo mena apertamente la sferza e s’acquista fama nella posterità». Ed è questo un tema fondamentale fra quelli dibattuti in quegli anni, che ritroveremo nel 1826 nel primo scritto del giovane Giuseppe Mazzini. «Venne Dante».
Così esordisce Berchet il 7 gennaio 1819 entrando nel tema scottante delle passioni politiche, a commento delle «idee di Sismondi» sul grande fiorentino. Dante esaminò l’eredità dei suoi precursori più immediati: la poetica dei Trovatori; le poesie dei Siciliani e la popolarità della loro lingua; lo spirito religioso, meditativo, teologico e la popolarità di tutti gli argomenti desunti dalla fede. «Vide – è Berchet che parla – che nessuno de’ poeti moderni che lo avevano preceduto s’era giovato abbastanza dell’arte onde scuotere fortemente le anime, e che nessun filosofo era penetrato nei recessi del pensiero e del sentimento». Invece di Canti d’Amore, di Madrigali, di false Allegorie, Dante concepì nella sua alta immaginazione «tutto il mondo dell’invisibile» svelandolo poeticamente agli italiani. Al di là dello straordinario valore poetico, l’argomento scelto era «collegato più strettamente di qualunque altro con tutte le passioni politiche de’ tempi, con tutte le memorie della patria, di gloria, di fazioni civili, di virtù e di delitti magnanimi, perocché tutti i morti illustri dovevano ricomparire innanzi a’ viventi su questo nuovo teatro aperto dal Poeta». Dal Conciliatore all’Antologia, il periodico di lettere, scienze ed arti che inizia le pubblicazioni nel 1821, col prevalente impegno di Giampietro Vieusseux e di Gino Capponi. La rivista, accanto ai numerosi interventi di natura letteraria, raccoglie e porta avanti l’impegno del Conciliatore di Berchet che prima della soppressione aveva evidenziato i contenuti culturali, politici e civili della figura e dell’opera di Dante Alighieri e dell’età che fu sua. E lo fa con firme autorevoli, quali quelle di Sebastiano Ciampi, Giuseppe Montani e Niccolò Tommaseo. Uno spiraglio si era aperto già nel 1823, allorché l’Antologia aveva illustrato il «Piano per una nuova edizione della Commedia di Dante, degna di lui e della sua patria». Un saggio che inizia con queste parole: «La Commedia di Dante è il più bel poema che possa mostrare con della compiacenza l’Italia». È tuttavia di Sebastiano Ciampi il primo intervento significativo, nel 1825, legato al tema prevalente della lingua: il toscano come lingua superiore, che si impone nella pluralità dei dialetti, in quanto accolta e praticata anche dagli scrittori autorevoli delle altre regioni. Tale lingua può essere perfezionata ed integrata con vocaboli di diversa provenienza per farne una lingua veramente nazionale; la parlata dialettale può essere altresì epurata, poiché come già accaduto ad Atene e Roma «non è il solo parlar del popolo che dia la legge per li scrittori. Il popolo dà l’impronta al vocabolo; ed i buoni scrittori fanno la scelta». Il carattere prevalentemente letterario degli scritti su Dante si protrae fino al 1826-27, dopodiché si può rilevare una specie di “svolta”; anche a seguito del saggio inviato a Vieusseux dal giovanissimo Giuseppe Mazzini, Dell’amor patrio di Dante. Si tratta come è noto, del primo testo dell’Apostolo, che inaugura l’edizione nazionale degli Scritti. In realtà il giovane appena ventenne andò incontro ad un rifiuto, poiché dopo meditata riflessione quel brano non superò il giudizio di Vieusseux, direttore della rivista, e lasciò perplesso lo stesso Tommaseo, redattore e più ancora una specie di condirettore senza larghi poteri. Quel testo era eccessivamente impetuoso, usava uno stile troppo appassionato, con impeti quasi violenti per poter superare l’esame attento della censura. Mazzini riscopriva in Dante «il padre della nazione», considerava il motivo politico come dominante in tutta la parabola della Commedia, vedeva il poema dantesco come prefigurazione di un’unità di lingua, di costumi, di civiltà, destinata fatalmente a proiettarsi sul piano politico, a tradursi in unità nazionale. «Sul finire, credo, dell’anno anteriore (1826) – annoterà lo stesso Mazzini molti anni più tardi – io avevo scritto le mie prime pagine letterarie, mandandole audacemente all’Antologia di Firenze, che, molto a ragione, non le inserì e che io avevo interamente dimenticato, finché le vidi molti anni dopo inserite, per opera di Tommaseo, nel Subalpino: versavano su Dante che dal 1821 al 1827 avevo imparato a venerare non solamente come Poeta, ma come padre della nazione». Quell’appassionato intervento era provocato dalla reazione di Mazzini alle riserve mosse allora da alcuni critici a Dante, di cui apprezzavano le capacità letterarie, rimproverandogli tuttavia la mancanza di «amor patrio». Inquadrandolo nella realtà storica del suo tempo, Mazzini confronta e ribalta tale affermazione, esaltando in Dante ancor più delle doti poetiche, le virtù del cittadino. Servì la patria, combattendo e governando, allorché fu chiamato a quei doveri: ma rifiutò, come tanti altri poeti fecero nelle varie epoche, di «prostituire l’ingegno, e la penna alla tirannidi politiche».
Pagò di persona, con le sofferenze e con l’esilio, conservando intatta, anzi esaltandola, la propria dignità. «Vestita la severità di un giudice flagellò le colpe e i colpevoli, ovunque fossero; non ebbe riguardo a fazioni, a partiti, ad antiche amicizie; non servì a timor di potenti, non s’inorpellò ad apparenze di libertà, ma denudò con imparziale giudizio l’anime ree, per vedere se il quadro della loro malvagità potesse ritrarre i suoi compatrioti dalle torte vie, in che s’erano messi». In tutti i suoi scritti, prosegue Mazzini, affiora sempre sotto forme diverse l’amore immenso ch’ei portava alla patria; amore, che “non nudrivasi di pregiudizietti”, o di rancori municipali, ma di pensieri luminosi d’unione, e di pace; che non restringevasi ad un cerchio di mura, ma sibbene a tutto il bel paese, dove il sì suona, perché la patria d’un italiano non è Roma, Firenze o Milano, ma tutta Italia».
«O Italiani! – è l’appello finale rivolto soprattutto ai giovani – Studiate Dante; non su’ commenti, non sulle glosse; ma nella storia del secolo, in ch’egli visse, nella sua vita, e nelle sue opere». Può apparire un paradosso: ma quel testo mai pubblicato, letto e riletto e conservato scrupolosamente da Tommaseo fino alla pubblicazione dieci anni più tardi, offriva un’interpretazione di Dante destinata ad influenzare fortemente i redattori dell’Antologia, in particolare proprio Niccolò Tommaseo. Emblematico è l’ampio saggio che lo scrittore dalmata dedica al Poeta nell’unificato clima del 1831, «di un nuovo commento alla Divina Commedia». Si deve mettere da parte l’analisi filologica della Commedia per tracciare un diverso profilo di Dante, più organico, collocandolo nella storia del suo secolo, collegandolo agli eventi, soffermandosi sul Poeta ma anche sul cittadino. Fermezza, imparzialità, onestà, sincerità sono i requisiti fondamentali di Dante: «la sua grandezza gli rendeva intollerabile l’ipocrisia». Animo religioso, distinse la religione dai suoi ministri, troppo spesso indegni di rappresentarla. Uomo, più che Poeta. «Vario e naturale, conciso ed esatto, severo ed ameno, tragico e comico, dotto e Poeta, Fiorentino e Italiano, simbolo quasi delle contraddizioni ch’esaltano e umiliano, che rendono gloriosa ed infelice l’umana natura. Chi cerca in esso non altro che il Poeta, non saprà mai degnamente gustarlo». Non si deve onorare Dante Poeta e denigrare poi quel «cittadino disamorato, avverso all’ara, al sacerdozio, a qual si sia civile reggimento». Gli fa eco R. Meconi, nel 1832, polemizzando con certi “distinguo” di parte cattolica, che confondevano la fede con la veemente condanna degli intrallazzi politici del successore di Pietro e dei suoi manutengoli. A Dante politico dedica pagine incisive, in quello stesso 1832 (l’ultimo anno di pubblicazione dell’Antologia), l’autore anonimo che si cela sotto le lettere “X. X.”. «Dante è l’uomo pubblico dell’Italia, il Poeta filosofo della nazione, il rigeneratore della patria, il riformatore della civiltà del suo secolo». Dalle pagine di Berchet sul Conciliatore, attraverso quelle inviate da Mazzini all’Antologia, alle altre di Montani e Tommaseo le dispute accademiche e letterarie sulla interpretazione di certi passi della Commedia hanno ormai lasciato il posto – nell’arco di meno di quindici anni – al padre politico e civile della nazione italiana.
Maurizio Costanzo

