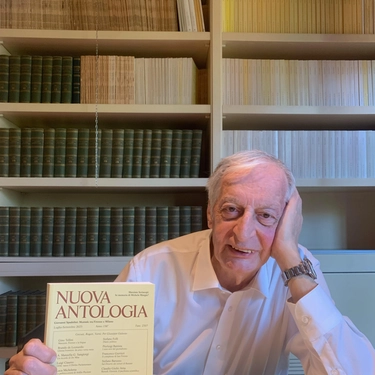Max Pezzali
Firenze, 7 maggio 2021 - Ogni decennio ha il suo canone letterario, musicale, cinematografico, ogni decennio ha i suoi oggetti che conseguentemente diventano reliquie (con un tasso di invecchiamento sempre più rapido, bastano un paio d’anni e sei reliquia, nel caso di Clubhouse poche settimane). Ogni decennio ha il suo sociologo di riferimento. Il mio è Max Pezzali, che ascoltavo da ragazzino sulla cassetta, non c’erano ancora iTunes e Spotify, non c’erano ancora gli altoparlanti wireless. Questi ricordi sono il privilegio dell’essere nati a metà degli anni Ottanta. Non abbastanza grandi, nel decennio successivo, da aver fatto sufficienti cazzate, non abbastanza piccoli da aver coltivato la nostalgia di un passato non vissuto. Capirete dunque la gioia quando in libreria è arrivato “Max 90” (Sperling & Kupfer), il libro dei ricordi dell’ex frontman degli 883. Certo, sono consapevole che la mia nostalgia oggi ha un valore enorme per case editrici, cinematografiche e televisive, d’altronde basta sfogliare il catalogo di Netflix per capire qual è il target, qual è il pubblico di riferimento. Però chissenefrega, Max Pezzali resterà sempre il miglior cantore degli anni Novanta, specie per chi poi come me è figlio della provincia. “Mi manca ascoltare gli 883 di nascosto con il walkman, tornando a casa alle cinque all’ennesima serata in cui ho messo la camicia ma nessuno mi ha filato, ché non so ballare, non so essere figo, non so nemmeno sembrare simile a chi non va a casa da solo”, scrive Lodo Guenzi, anche lui figlio di metà degli anni Ottanta, nella prefazione al libro di Max Pezzali da Pavia. Max 90 è una stupenda raccolta di oggetti e situazioni, un museo cantato, sulle quali gli 883 hanno scritto iconiche melodie. Non un mero elenco ma il florilegio ragionato di uno che avrebbe potuto scrivere saggi di sociologia e invece s’è messo a fare canzoni. Il deca, quelle diecimila lire che a malapena servivano a prenderti una pizza e poi non restava più niente per la serata, le città da sogno dove scappare, come New York (mi son sempre chiesto che cosa sognassero invece da ragazzini quelli nati e cresciuti a Roma o Milano), la sala giochi, che era, dice Pezzali, il modo più economico per incontrare le persone, il cinquantino. Avete presente, sì, quelle serate in cui ci si metteva a guardare le foto delle vacanze. Ecco, a leggere il libro di Pezzali si ha la stessa sensazione; sono immagini dal passato, quando - come direbbe Edoardo Nesi - c’era ancora un’idea del futuro, sono una lunga raccolta di figurine Panini, soltanto che al posto dei calciatori ci sono il due di picche, la regola dell’amico, la ragazza mitologica. Se vogliamo, tutta la produzione di Max Pezzali è un eterno “Storia della mia gente”, solo che la sua gente siamo tutti. Tutti quelli che capiscono che cosa dice quando parla della provincia, anche dei suoi aspetti deteriori. Rolling Stone gli ha chiesto in un’intervista perché non se ne sia andato da Pavia, col successo. “È l’effetto ‘Saigon, merda’ di Apocalypse Now. In Vietnam non vedevi l’ora di tornare a casa; a casa, di tornare in Vietnam. Io sono cresciuto in una provincia… molto provincia. Sai quell’ambiente in cui c’è l’idea che tutti ti osservino, ti giudichino, parlino di te? È stressante, ma anche uno sport estremo, un vivere sotto pressione che ti forma (ride). E poi a me piace girare il mondo per avere un luogo mio in cui raccontarlo”, ha risposto lui. Lo dice anche Cesare Pavese nella Luna e i falò: “Un paese ci vuole, non fosse che per il gusto di andarsene via. Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c'è qualcosa di tuo, che anche quando non ci sei resta ad aspettarti”. Che sia Pavia o Lastra a Signa, poco cambia.