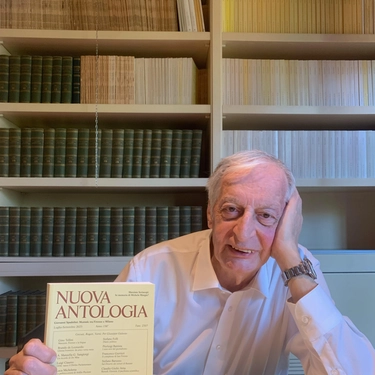Un'immagine del carcere di Sollicciano (New Press Photo)
Firenze, 8 febbraio 2019 - E' la lontananza dai figli il problema più pressante e più angosciante per le detenute: è quanto emerge dal rapporto conclusivo del progetto pilota di "empowerment" per donne detenute "Women In Transition - Wit" promosso da Società della Ragione col sostegno dell'otto per mille della Chiesa valdese. Tra i tanti aspetti approfonditi dalla ricerca, quello sulla lontananza dei figli, vista da tutte le recluse come fattore di stress, sia tra gli operatori del carcere, sia fra le donne detenute. Uno stresso dovuto alla lontananza forzata e ancora di piu' alla preoccupazione di chi possa prendersi cura dei bambini in loro assenza.
"E' stato uno shock, prima di tutto lasciare i miei figli a casa, l'unica cosa che a me premeva era quello", ha detto una reclusa. La ricerca ha raccolto le testimonianze delle detenute del carcere Sollicciano di Firenze e del carcere Don Bosco di Pisa. Il problema più pressante è quello di come mantenere i rapporti con i figli che sono rimasti fuori. I colloqui e le telefonate diventano un assillo. Negli ultimi anni qualcosa è stato fatto per favorire le telefonate, venendo incontro soprattutto alle esigenze delle persone straniere, che incontrano particolari difficoltà a mettersi in contatto con i familiari lontani. Tuttavia, è spiegato nella ricerca, il contrasto fra l'esigenza di avere contatti coi familiari (a volte drammatica quando la detenuta è il sostentamento della famiglia) e la macchina burocratica, è ben presente, ed è particolarmente duro per le straniere, che possono contare solo sulle telefonate visto che i figli vivono lontano.
Dice una di loro:" Io telefono per dieci minuti e per sette la bambina piange, abbiamo solo tre minuti per parlare, non si capisce niente. Una volta a settimana, per noi stranieri è dura". E un'altra detenuta: "Lavoro con la psicologa per andare in permesso a trovare mia figlia di otto anni. Suo padre non vuole portarla qui in carcere logicamente, ha ragione da una parte. Noi siamo divorziati, quindi è più difficile, non c'è nessun contatto, nessun rapporto tra me e lui".
E un'altra reclusa ancora: "La persona detenuta è vista come malata incurabile ed è bene che il bambino non abbia contatto, non si coglie la positività della continuità del rapporto, ma solo l'aspetto negativo del bambino che in modo traumatico viene portato dentro il carcere. Può anche non essere piacevole per il bambino, ma va valutato cosa è meglio, il rapporto coi genitori o cosa? Si dice: voi proteggete il genitore, noi il minore, ma non sono interessi confliggenti". Dalla ricerca, che non riguarda soltanto le detenute madri ma tutti gli aspetti realtivi alle donne in cella, è stata avanzata una proposta rivolta alle istituzioni giudiziarie e penitenziarie, ma anche alla Regione e agli enti locali: promuovere occasioni formative "trasversali" (con operatori di diversa funzione) su un nuovo modello di carcere "risocializzante e responsabilizzante" e sui percorsi di empowerment, individuale e ambientale, prendendo spunto dai risultati di questo progetto.